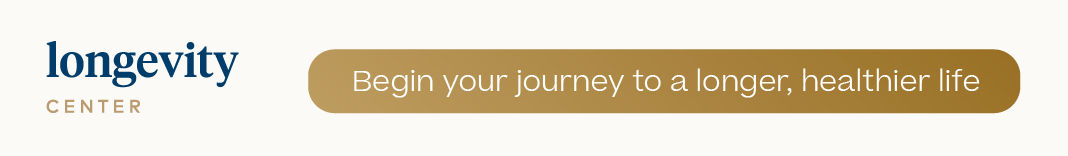Almanacco dei miti gastronomici (con sorprese). La pasta? Rubata agli arabi. E la pizza? Arriva da Bisanzio…
copyright: Il Sole 24 ore
I napoletani? Mangia cavoli. I siciliani? Consumatori di maccheroni. I luoghi comuni, i miti, nella gastronomia son mobili qual piuma al vento. Basta andare indietro di qualche centinaio d’anni e tutte le nostre certezze vengono messe sottosopra. I veneziani erano noti per le loro ostriche, pregiatissime quelle raccolte all’interno dell’Arsenale, le menziona anche Giacomo Casanova. Oggi l’Arzanà de viniziani, così Dante nell’“Inferno”, non va famoso per la qualità delle sue ostriche, quanto piuttosto per le attività del suo più importante inquilino: il Consorzio Venezia Nuova. Certo, ci sono anche alcune certezze che travalicano i secoli: le mortadelle di Bologna, o i torroni di Cremona, per esempio.
La pasta? Abbiamo imparato a usarla dagli arabi
I miti sono in genere piuttosto recenti, spesso generati nell’Ottocento. Cosa c’è di più tipicamente italiano della pasta col pomodoro? Be’, cosa c’è di meno italiano della pasta col pomodoro, visto che la pasta secca ce l’hanno data gli arabi (arrivata via Sicilia, ecco spiegato il perché dei siciliani mangia maccheroni), mentre il pomodoro è arrivato dall’America. La prima ricetta – quella sì napoletana – che prevede di mettere il pomodoro sulla pasta è datata 1839.
Lo stesso vale per la pizza. Un disco di pasta usato come piatto è citato persino nell’”Eneide” (Virgilio scrive che i troiani affamati si ritrovano costretti a mangiare le loro mense) e che qualcosa di assai simile sono pure la piadina romagnola (non a caso Ravenna era la capitale dell’esarcato bizantino) e lo zighinì del Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia). In ogni caso il pomodoro arriva sulla pizza soltanto a Ottocento inoltrato.
La gastronomia nasce meticcia
Il genio italiano in cucina, quindi, non è stato tanto quello di inventare cibi nuovi, quanto la capacità di assemblare alimenti già esistenti e di creare qualcosa che prima non c’era. La gastronomia è intreccio, meticciato, la purezza etnica tra i fornelli quasi non esiste. Quasi, perché in realtà qualcosa di puramente italiano c’è, solo che non ce lo ricordiamo. Si tratta dell’insalata. L’uso di mescolare erbe diverse, di condirle con olio, aceto e sale (da cui insalata) è assolutamente italiano e dall’Italia è stato esportato nel resto d’Europa. «Trovando alcuni erbucci da salegiate come sono raponzori, salbastrella, primifiori e ruchetta et altri erbi», scrive Giovanni Sercambi nel suo “Novelliere”. Corre l’anno 1402 ed è la prima volta che si trova nominata l’insalata, ma, come appare ben chiaro, mettere insieme «erbucci da salegiate» doveva essere una pratica conosciuta da tempo.
Ora però torniamo ai luoghi comuni su base regionale. L’attore comico mantovano Tristano Martinelli (a lui è attribuita la primogenitura della maschera di Arlecchino) nel 1615 scrive in una lettera: «Un fiorentino a magnare pesciolini d’Arno, un venetian a magnare ostriche, un napolitan broccoli, un cicilian macaroni, un genovese gatafruta, un cremonese fasoli, un milanese buseca» (la gatafruta, o gattafura, è una torta di erbe e formaggio, buseca vuol dire trippa). Chissà, forse le manie regionali servivano a far ridere, un po’ come avviene oggi, con i romani infingardi, i veneti scemi e i siciliani pigri. In ogni caso l’elenco ci dà un’idea ben precisa di quali fossero i cliché alimentari di inizio XVII secolo: a Napoli si mangiano broccoli, in Sicilia pasta, a Venezia ostriche e a Firenze pesce di fiume, tutte cose che oggi appaiono ben lontane dall’identificare alcunché. Il discorso vale pure per Genova, Cremona e Milano, ai nostri giorni simboleggiate dal pesto, il torrone e la mostarda, e dal risotto e l’ossobuco. Torte salate, fagioli e trippe non sono scomparse dalle tavole, ma di sicuro non ricoprono più il ruolo di portabandiera delle rispettive cucine.
Facciamo un salto più in là di qualche decennio, fino a metà Seicento, ed ecco il gioco dell’oca disegnato dal bolognese Giuseppe Maria Mitelli. Questi fu un maestro dell’incisione e ne realizzò di ogni tipo, compresa una serie di 33 soggetti che rappresentavano i giochi popolari in uso all’epoca. Quello che ci interessa è il gioco di Cuccagna (il luogo mitico dove meno si lavora più si magna), nel quale, scrive l’autore, sono elencate «le principali prerogative di molte città d’Italia circa le cose mangiative». Alcune le riconosciamo anche ai nostri giorni, come la mortadella di Bologna, i cantucci di Pisa o il torrone di Cremona. Altri ci appaiono meno familiari: Napoli ancora una volta identificata con gli ortaggi, broccoli, in questo caso; Roma con le provature (provole), formaggio di bufala che al tempo arrivava nella città papale dalle non lontane, e oggi scomparse, paludi pontine. I veneziani sono passati dalle ostriche al moscato, un vino dolce che oggi si beve piuttosto raramente, mentre i milanesi rimangono fermi sulle loro trippe. Interessante il caso di Piacenza, identificata col formaggio.
Quando il cacio “piasentino” surclassava il “parmesano”
Al tempo – i parmigiani smettano di leggere o almeno ingurgitino un Maalox – il «cacio piasentino» era ben più famoso e pregiato di quello «parmesano». Ora, è vero che Giovanni Boccaccio, nella terza novella dell’ottava giornata del “Decameron”, per illustrare la contrada di Bengodi, scrive: «Eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattuggiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e raviuoli, e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan giù, e chi più ne pigliava più se n’aveva».
Il parmigiano tuttavia era roba popolare, un po’ grossolana; se si voleva condire la pasta con un formaggio raffinato bisognava scegliere quello di Piacenza, ma andava benissimo pure quello di Lodi, altro luogo dove si produceva un cacio eccellente. Oggi il mondo è decisamente cambiato: il formaggio più pregiato si ottiene a sud del Po e solo lì si può chiamare parmigiano reggiano (province di Modena, Parma, Reggio Emilia, parte di quelle di Mantova e di Bologna). Tutto ciò che viene prodotto a nord del Po assume genericamente il nome di grana padano e viene considerato di diversa qualità. Il cacio piacentino, ai nostri giorni, è un pecorino con zafferano prodotto nella provincia di Enna, in Sicilia. Il granone lodigiano si è estinto dopo la scomparsa, negli anni Settanta, delle marcite dove si nutrivano le mucche destinate a dare il latte per la produzione del granone. Dagli anni Duemila si è cercato di riprodurre qualcosa di simile, ottenendo così il “tipo granone” o “tipico lodigiano”.
Come nasce il maccherone napoletano
Cambia il mondo, cambiano i luoghi comuni. Emilio Sereni, romano, esponente di punta del Pci nel dopoguerra, storico dell’agricoltura (si trattava di un signore che conosceva, tra le altre lingue, il sumero e l’accadico) dedica una sua opera proprio al passaggio dei napoletani da mangiafoglie a mangiamaccheroni. Il cambiamento avvenne nel XVII secolo, quando a causa di alcune carestie non fu possibile rifornire i napoletani di carne, che si abbinava alle verdure per il necessario apporto proteico. Il binomio carne-cavoli fu sostituito da quello maccheroni-formaggio, pure questo secondo era in grado di fornire il necessario supporto proteico e nutrizionale, anche se meno nobile rispetto al primo. La storia dei maccheroni a Napoli comincia da lì.
if (document.currentScript) {