

Nell’anno di san Francesco sentiremo (già la sentiamo) ricorrere la domanda: cosa farebbe, cosa direbbe san Francesco, se tornasse oggi, in un mondo dilaniato dalle guerre (cinquantasei conflitti armati in corso, la cifra più grande dalla Seconda Guerra Mondiale), dalla violenza (in un anno sono stati segnalati in Italia più di un milione di messaggi di odio sulla rete: principalmente contro gli stranieri, le donne, gli ebrei), dalla disuguaglianza sociale (sono 5,7 milioni gli individui in povertà assoluta in Italia; 2,5 milioni in Polonia), dall’ingiustizia?
E noi come reagiremmo alla sua venuta? Se l’era chiesto il critico letterario Carlo Bo, nei primi anni ottanta, in un breve e denso testo, intitolato Se tornasse San Francesco (Il nuovo Leopardi, 1982); se lo chiede il frate minore Enzo Fortunato, nel suo recentissimo libro, che porta quasi lo stesso titolo: E se tornasse Francesco? (San Paolo, 2025).
La risposta di Carlo Bo non è ottimistica: “la maggior parte delle volte che viene a battere alla nostra porta facciamo finta di non sentire e non apriamo e diventiamo strumenti della sua perfetta letizia”. E se lo sentiamo, rispondiamo: “Vattene, tu sei un semplice idiota, qui non ci puoi venire”. Oppure, nel migliore dei casi, se non ci siamo tappati le orecchie o non abbiamo alzato la voce per cacciarlo, compiamo un gesto a cui, proprio nell’anno a lui dedicato, dobbiamo fare molta attenzione: “facciamo entrare nelle nostre case la sua leggenda e lasciamo fuori le sue verità che sono la pazienza, il perdono, l’amore”.
La tentazione di dipingere, nell’ottavo centenario della sua morte, un san Francesco pacifista, ecologista, una sorta di mite supereroe dell’uguaglianza e della giustizia (di cui abbiamo drammaticamente bisogno) è grande. Semplificare, proiettare una figura complessa, multidimensionale, su uno spazio ridotto, sulla superficie bidimensionale di un santino, della copertina di un libro, di un giornale, è il modo più elegante di addomesticarla. E fraintenderla. Ma forse Carlo Bo non è stato sufficientemente pessimista, forse potremmo reagire come il Grande Inquisitore di Dostoevskij: processando e condannando san Francesco per il suo intollerabile, utopistico modello di vita, che ci costringe a ignorarlo, rifiutarlo, a farne una leggenda, una devozione, un santino. Per una simile reazione, occorrerebbe un certo spessore intellettuale; forse, più banalmente, sposteremmo il problema dal piano dell’etica e della teologia, a quello della salute mentale, e lo giudicheremmo pazzo, con tanto di diagnosi psichiatrica: ordineremmo un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Oppure lo prendiamo sul serio, lo ascoltiamo, impariamo il suo linguaggio, verbale e non verbale, fatto di parole, gesti, azioni. “Di tutto il corpo faceva lingua”, si è scritto di lui.

Quale linguaggio parlava san Francesco?
Il linguaggio della fraternità.
Della pace, certo, dell’ecologia, anche, ma della fraternità innanzitutto, da cui derivava il resto. Francesco voleva essere fratello di tutti: di ogni donna e uomo, animale, creatura vivente, del sole, del vento, dell’acqua, della terra, perfino della morte. Ma più di tutti voleva essere fratello dei poveri e dei malati. Aveva la predilezione per gli ultimi, per i fragili. Non era filantropia, era immedesimazione. Non si limitava a servirli, viveva con loro, come loro. Perché erano i più simili a Cristo. Quando incontra il lebbroso, non gli dà soltanto da mangiare, lo abbraccia, condivide il pasto dallo stesso piatto.
Il linguaggio della follia.
La promiscuità con il lebbroso, la spogliazione totale davanti al padre e al tribunale ecclesiastico; l’ostinata rinuncia ad ogni bene materiale e a una abitazione (fino alla morte si batté perché la Regola vietasse il possesso di case, ma perse); la pacifica e incosciente visita al Sultano, nel bel mezzo di una crociata, per annunciargli il messaggio evangelico dell’amore, della pace; la predica agli uccelli, il dialogo con il lupo. Tutti gesti riconducibili a una delle (numerosissime) voci del DSM (Manuale statistico e diagnostico dei disturbi psichiatrici). Lo psichiatra Vittorino Andreoli dedica un capitolo a san Francesco nel libro Follia e santità (Rizzoli, 2005), mostrando come queste due forme misteriose di vita possano coesistere, senza essere l’una dell’altra spiegazione. È così assurda, scandalosa, sconveniente, la radicale scelta di prossimità agli ultimi, la povertà incondizionata, da confinare necessariamente con la follia.
Il linguaggio della poesia.
La prima poesia in italiano volgare è sua (lo sappiamo, l’Indovinello veronese è un testo più antico, ma non è una poesia), ed è un inno di lode. Una poesia benedicente Dio, il creato, l’umanità, la sua bellezza, ma anche la sua caducità. Versi che cantano il bello e il senso di tutto ciò che esiste, e fondono ogni uomo, creatura animata e inanimata, in un legame di fraternità. Siamo tutti (tutto) esseri creati, destinati dunque alla trasformazione e alla consunzione, sottomessi al ciclo della vita e della morte: belli anche per questo. Belli e simili nel loro destino (anche di malattia e morte), nella loro possibilità di essere al servizio gli uni degli altri. Inizia così la nostra letteratura in lingua italiana, con questi versi umanissimi di san Francesco.
Prenderlo sul serio vuol dire tornare alle origini: del linguaggio poetico, che mette in luce la bellezza e caducità di ogni cosa; del linguaggio della follia, con i suoi gesti sconsiderati, compiuti per un bene maggiore del proprio: del linguaggio della fraternità, che epura le relazioni da ogni forma di violenza, rispetta e considera l’altro un proprio simile, con pari diritti e bisogni. Vuol dire tornare all’origine di ciò che è umano in noi: alle radici.
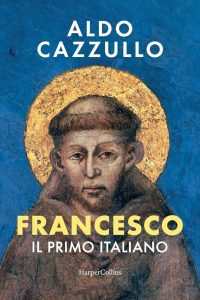
Allora, come vogliamo ricordarlo, nell’ottavo centenario della sua morte, il santo di Assisi? Con i tratti serafici della biografia ufficiale di Bonaventura, rievocando una leggenda? Forse non basta, occorre attingere a quelle precedenti e alternative, fatte scomparire a favore dell’agiografia ufficiale, ma poi riapparse, da cui emerge un san Francesco scomodo, non privo di contraddizioni, squilibrato, umano. Ne parlano ampiamente Alessandro Barbero in San Francesco (Laterza, 2025) e Aldo Cazzullo in Francesco. Il primo italiano (HarperCollins, 2025). Letture consigliatissime.
E, soprattutto, come vogliamo celebrarlo, rendergli onore? Potremmo provare a reimparare il suo linguaggio: di fraternità, di follia, di poesia. Campi in cui siamo diventati analfabeti. Forse per questo non ci capiamo più, neanche tra “simili”, conterranei, familiari, coinquilini, troppo presi a difendere i nostri beni, le nostre idee, i nostri interessi. Forse per questo ci ignoriamo, feriamo, combattiamo, ghiacciando i nostri cuori, armando i nostri confini. È un secolo triste e buio, quello in cui celebriamo san Francesco, forse più buio del suo. Francesco di Assisi può riportare luce e gioia: letizia, come la chiamava lui.
Nell’ultimo libro scritto prima di morire, intitolato Gioia (Einaudi, 2025), il grande psichiatra Eugenio Borgna spiega cos’è la letizia francescana: “La letizia, con cui a volte si confonde la gioia, è quella francescana, per questo ci fa vedere le persone nel loro aspetto luminoso, non solo in quello umbratile, facendoci capire che in ciascuno di noi luci e ombre si alternano, e le ombre si diradano solo se sappiamo incontrare gli altri con amore, e con sensibilità”.
La letizia: altra cifra del linguaggio francescano. Ce ne basterebbe poca, finanche imperfetta, per inaugurare un nuovo modo di comunicare, di venirsi incontro, di riscoprirci fratelli.















