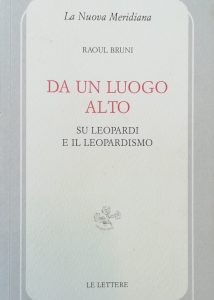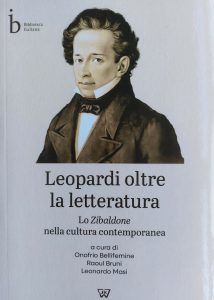Raoul Bruni, professore associato all’Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia – dove ha diretto la cattedra di Letteratura Italiana tra il 2021 e il 2022 – è uno dei personaggi di riferimento nel panorama intellettuale italiano in Polonia. Autore di numerose pubblicazioni e membro del comitato scientifico del Centro Nazionale Studi Leopardiani, ha dedicato la maggior parte del suo impegno a Leopardi e alla sua eredità letteraria e filosofica.
Uno studioso i cui imperscrutabili destini di vita, dopo gli studi a Firenze e il dottorato all’Università di Padova, hanno portato sulle rive della Vistola.
Come molti italiani, sono banalmente arrivato in Polonia a causa di una relazione sentimentale. Ho iniziato a lavorare qui insegnando prima alla SWPS di Varsavia e poi all’Università Pedagogica di Cracovia e poi.
Il contatto con la Polonia cosa ha portato al tuo approccio alla letteratura?
Il vivere in questo Paese ha sicuramente arricchito il mio sguardo sulla letteratura. Varsavia in particolare mi ha influenzato. Una città, ricostruita da zero, che trovo interessante, moderna, stimolante, piena di librerie e con una scena letteraria più viva di quella di molte città italiane, basta vedere il pubblico che attira un reading di poesia. Varsavia non lascia indifferenti. Così ho trovato naturale approfondire le relazioni letterarie tra Italia e Polonia, e se gli autori polacchi in Italia sono studiati in modo soddisfacente credo invece si debba approfondire di più la ricerca sugli italiani, scrittori e giornalisti, in Polonia. Mi riferisco ad esempio al soggiorno di Curzio Malaparte a Cracovia e Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale in cui scrive pagine che confluiscono nel romanzo Kaputt, la cui traduzione in polacco ha raccolto un certo successo. E poi altri scrittori come Guido Piovene che scrisse cronache dalla Polonia del dopoguerra per il Corriere della Sera, articoli di cui sto curando una prossima pubblicazione.
Sei stato il primo ad organizzare un convegno su Leopardi in Polonia. Esiste secondo te un aspetto particolare che caratterizza il recepimento di questo autore in Polonia?
A differenza di altri Paesi qui in Polonia Leopardi è poco conosciuto. Autore che tra l’altro in Italia, anche grazie ad un film di successo e una recente serie tv ha accresciuto la sua popolarità. Di Leopardi in Polonia ci sono alcuni importanti studi e traduzioni di Joanna Ugniewska, Jarek Mikolajewski e Stanisław Kasprzysiak grazie ai quali alcuni poeti polacchi, come Zagajewski, si sono interessati all’autore dell’Infinito, ma non c’era mai stata a livello universitario un’iniziativa di studi dedicata a Leopardi. Il convegno che ho faticosamente realizzato, grazie ad un generoso supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, ha cercato di aprirsi ad un pubblico popolare con anche un panel di poeti e studiosi polacchi con traduzione simultanea. In sintesi possiamo dire che di Leopardi c’è una ricezione abbastanza confinata al mondo accademico, si sente il bisogno di una maggiore attività di ricerca e sicuramente di una maggiore diffusione delle opere di Leopardi, ad esempio la traduzione polacca delle “Operette morali” è fuori pubblicazione e la copia della Biblioteca Universitaria di Varsavia è consumata… Sono comunque contento della ricaduta del convegno di altre iniziative leopardiane che ho organizzato qui a Varsavia, come un recente incontro sull’edizione polacca dell’epistolario che ha perfino conquistato spazio sulle pagine della cultura del Corriere della Sera.
Hai insegnato a Padova prima di trasferirti in Polonia, hai trovato differenze nell’approccio con gli studenti polacchi?
Bisogna sottolineare la grande attenzione che c’è in questo Paese verso l’Italia in generale, studio della lingua incluso. Un’attenzione confermata anche dal successo della vostra Gazzetta Italia. A Varsavia un po’ in tutti i quartieri si notano insegne di scuole che insegnano l’italiano, il che significa che c’è mercato e, anche a livello universitario, le facoltà di italianistica sono sorprendentemente numerose. È pur vero che oggi la laurea in italianistica, lavorativamente parlando, ti apre più porte in Polonia che in Italia. Per quanto riguarda il livello degli studenti in genere sono soddisfatto, sono molto preparati sul piano linguistico, hanno un primato quasi europeo di competenza linguistica. Noto meno interesse verso la letteratura, ma è un fenomeno generale.
Qualche strategia per aumentare l’attrattività della materia?
Spiego la letteratura cercando di collegarla all’attualità. Ad esempio Leopardi è un autore che appare oggi più contemporaneo di molti autori contemporanei, ha sempre avuto sguardo profetico tanto da progettare una “lettera a un giovane del ventesimo secolo”. E poi l’Italia, come la Polonia, non si può capire se non attraverso la letteratura. L’Italia, come anche la Polonia, fu divisa per secoli in vari Stati e ha sviluppato una unità culturale e linguistica soprattutto attraverso la letteratura: Dante, Petrarca, Machiavelli cardini di una cultura e di una lingua quando ancora non c’era un Paese. E per tornare a Leopardi il suo “Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani” è il testo forse più attuale e acuto su l’Italia moderna.
L’Intelligenza Artificiale è come un meteorite che piove sul sistema didattico?
I cambiamenti sono forieri sia di opportunità che di rischi. L’Intelligenza Artificiale, come spesso capita alle innovazioni, da alcuni viene vista come l’Apocalisse. Io non sono né tra gli entusiasti né tra gli apocalittici, credo piuttosto che come ogni novità tecnologica vada gestita in modo intelligente. Certo noi insegnanti dobbiamo prendere atto che potrebbe stravolgere il valore degli scritti degli studenti, bisogna trovare il modo di renderla compatibile con lo studio, magari è l’occasione per rivalutare le prove orali.
Non metterà in crisi la professione del traduttore?
Ho tradotto dei testi con l’AI e posso dire che non sono certo paragonabili al lavoro di un professionista. L’Infinito di Leopardi, ma anche tante metafore del linguaggio comune, non sono traducibili digitalmente. Al contrario l’Intelligenza Artificiale può rivelarsi uno strumento che agevola e potenzia il mestiere del traduttore che può fare molto di più in meno tempo. Infatti tra i miei amici traduttori nessuno è particolarmente preoccupato di perdere il lavoro.
L’italiano, nonostante il suo utilizzo sia sostanzialmente limitato al Bel Paese, rimane una delle lingue più studiate. È troppo romantico sostenere che lo studiano per il suo valore culturale?
No, non lo è. L’Italia ha un patrimonio culturale immenso e declinato in tutte le arti e le professioni, la conferma viene dal fatto che lo studio dell’italiano a volte diventa l’hobby o la passione per chi ha già alle spalle un certo percorso di vita, ci capita infatti d’avere studenti quarantenni che credo siano anche tra i maggiori fruitori dei corsi dell’Istituto Italiano di Cultura e delle scuole private.
In “Passato e Presente”, programma di RAI Storia che adoro, il grande Paolo Mieli chiede sempre agli intervistati di suggerire tre libri, tu quali consiglieresti per avvicinare chi parla italiano alla nostra letteratura?
Comincio con un classico: “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. Capolavoro della letteratura novecentesca italiana scritto da chi usava l’italiano come seconda lingua e in una città di cultura mitteleuropea come Trieste. Poi consiglio di leggere qualche libro di Carlo Ginzburg, storico e saggista che è anche un grande narratore. Infine vorrei suggerire la lettura di un romanzo appena uscito di un autore che varrebbe la pena tradurre: “Il detective sonnambulo” di Vanni Santoni (Mondadori).
In chiusura qualche pillola della cultura polacca che vivendo in questo Paese hai apprezzato?
Nonostante mi sia difficile leggere bene in polacco da quando sono qui ho approfondito la lettura di un grande poeta come Zbigniew Herbert, autore di un magistrale libro in prosa sull’Italia non ancora tradotto da noi, e poi in ambito cinematografico apprezzo molto Paweł Pawlikowski.