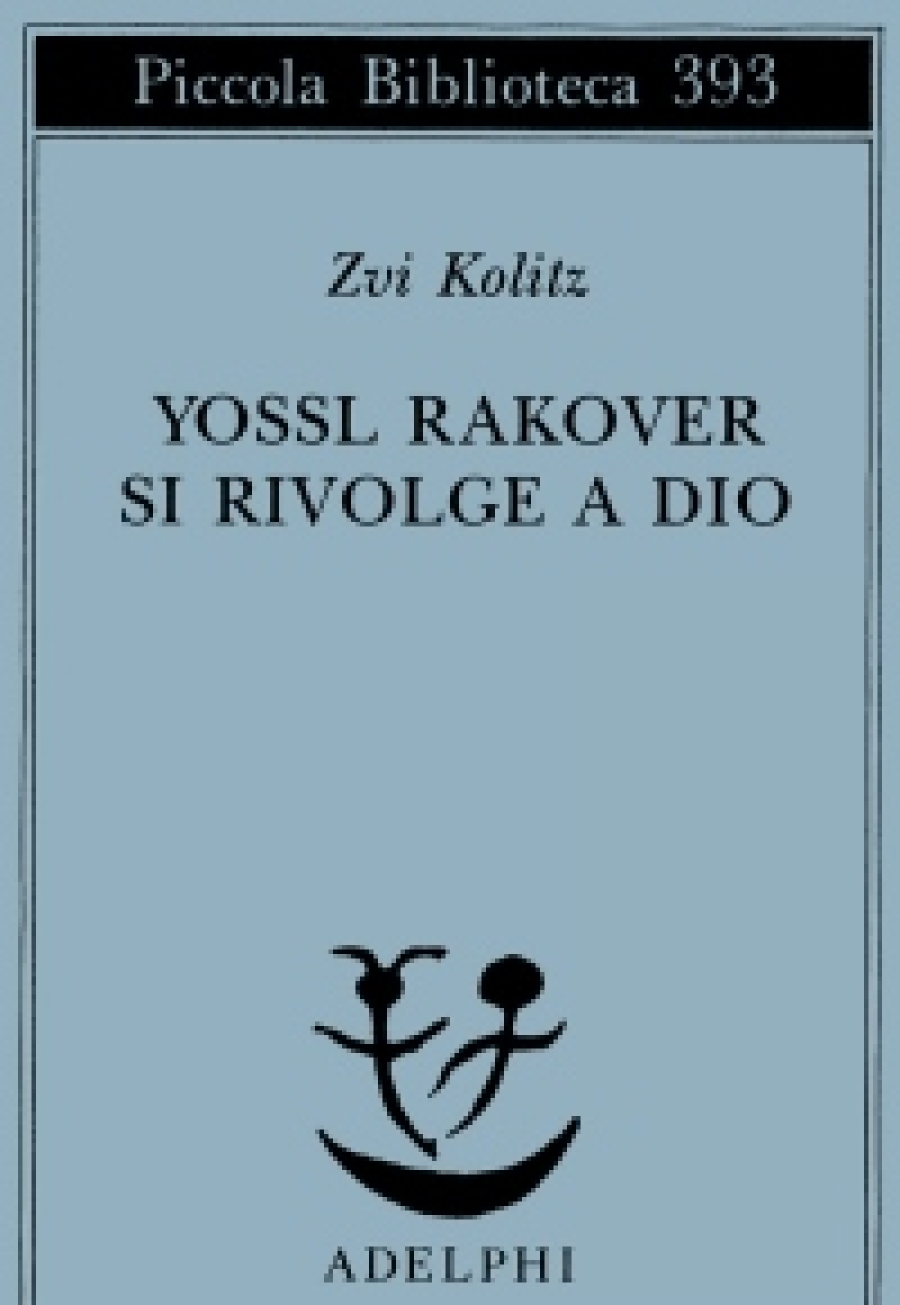
Una storia nella storia, una sorta di teatro nel teatro, la storia narrata e di chi scrive. Un caso controverso che porta alla luce la rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia, un caso unico. Non solo, c’è in questo esile racconto, un processo a Dio che è in qualche modo tipico del popolo eletto; un rovesciamento dello spirito cristiano del popolo che ama la legge, la Torah, più che Dio stesso, della ferita esistenziale e del Dio che nasconde il proprio volto e lascia che il giusto non riceva pietà.
E’ un testo esile, rivolto a Dio e rivolta contro Dio senza però una condanna definitiva. Come non ricordare il Processo a Dio con Ottavia Piccolo di qualche anno fa al Teatro Valle di Roma e come non pensare che è tipico del popolo eletto questo genere di processo? Non c’è ad esempio nulla di simile nel popolo armeno che pure è stato sterminato. Al di là dei numeri, calcoli macabri, lo sterminio di massa, senza una ragione almeno plausibile è un abominio della storia che si ripete, eppure gli ebrei considerano il proprio stato singolare, per non dire unico. Attenzione non c’è la maledizione di Dio, ma un processo.
La prima parte del libro di Zvi Kolitz è appunto la requisitoria, senza nessuna aggressività di un uomo che sta morendo nel ghetto di Varsavia dove, dopo il 1943 appunto non esiste più un ghetto e per chi, come me, ha visitato Varsavia il pensiero è impressionante. Se infatti si visita l’immenso cimitero ebraico ci si rende conto delle proporzioni della presenza ebraica nella città così come il suo stato di abbandono denuncia un popolo scomparso. Nel settembre del 1946 una rivista in lingua yiddish di Buenos Aires, El diario israelita, pubblicava Yossl Rakover si rivolge a Dio, presentandolo come l’ultimo messaggio di un combattente mentre la sua casa va a fuoco, un messaggio affidato ad una bottiglia e ritrovato tra ceneri e ossa carbonizzate. Come ogni messaggio affidato ad un messaggero vive poi di una sua vita propria. E’ il 28 aprile del 1943 e il testo esordisce come una professione di fede di grande forza: “credo nel sole, anche quando non splende; credo nell’amore, anche quando non lo sento; credo in Dio anche quando tace.” Queste righe sono state ritrovate sui muri di una cantina di Colonia dove alcuni ebrei si rifugiarono durante tutta la durata della guerra. Nella tragedia che incombe la morte immediata è giudicata una salvezza e come un nuovo Giobbe sente che tornerà – auspicandolo – presto alla terra, nudo come dalla terra è venuto.
Inizia così il dialogo con Dio ripensando al tempo nel quale il protagonista della vicenda viveva felice e vedeva il Signore come un benefattore mentre ora sente che è Dio ad essere in debito nei confronti dell’uomo quasi ci fosse un castigo per i peccati. Ma non è questo si affretta ad aggiungere, che è piuttosto l’accettazione cristiana della sofferenza (ndr). E’ come se Dio si fosse nascosto. L’uomo che rivolge il proprio messaggio a Dio non chiede pietà, né un occhio di riguardo rispetto a tutti gli altri, consegnati ad una fine atroce. Non è questo l’argomento di discussione. La vendetta resta l’ultima, unica arma per combattere perché gli ebrei adesso combattono e a Varsavia c’è stato l’unico tentativo dalla notte dei tempi – dopo la rivolta a Roma nel 135 d.C. sotto l’Imperatore Adriano che la represse – organizzata da parte ebraica. Quel Dio d’amore dei popoli ora è un Dio di vendetta perché in nome suo, il popolo eletto è trucidato. La vera originalità è che la fede diventa una scommessa con Dio e addirittura, paradossalmente, contro Dio di spore kierkegaardiano perché il fedele crede anche contro Dio stesso, crede anche se consegna gli uomini agli assassini, diventando il Dio degli assassini…ma la fede è più grande di tutto e anche se sparisse la fede in Dio mai verrebbe meno quella nella sua legge. Non è una fede grande è una fede assurda ed è questo l’aspetto sconvolgente del credo ebraico. La fede infatti non ha bisogno di nutrirsi della venerazione della perfezione. Pochi allora conoscevano la storia del ghetto di Varsavia e quando il vero autore si fece vivo, rivelandosi come un ebreo lituano nato nel 1919, poi emigrato in Palestina, ci fu un effetto destabilizzante. Qualcuno pensò che la vicenda di Yossl Rakover fosse inventata, altri cercarono e dettero un’attribuzione anche se a mio parere non è questa tortuosa vicenda l’essenziale né l’aspetto originale della narrazione, alla quale nulla toglie e nulla aggiunge, secondo me. Può essere utile conoscere la comunità ebraica della Lituania, narrata nelle note al libro dal curatore, che viveva in condizioni di assoluta considerazione: lì ad esempio il calendario ebraico contava più di altri e la fede era molto radicata. Tra l’altro l’autore, figlio di un rabbino e talmudista, era cresciuto in un rapporto quasi confidenziale con Dio con il quale dialogava “alla pari” e nello spirito di Dostoevskji secondo il quale “se Dio non esiste tutto è possibile”. Ripercorrendo la storia di Kolitz – che visse sempre in hotel con la moglie, ramingo, fissando solo una casa sul Mediterraneo anche se poi la sua vera dimora fu a New York – si assaggia anche il nomadismo tipico ebraico e il vissuto raccontato all’esterno. Ad esempio di “camere a gas” non si parla prima del 1945 e anche in Palestina l’eco non arriva. Lo Stato d’Israele, d’altra parte, si costituisce nel 1948, data spartiacque dopo la quale cambieranno molte cose nello scacchiere internazionale. A proposito di quella che Heidegger – che con l’ebraicità ebbe un rapporto contrastato (ndr) – definì la “ferita esistenziale”, il danno prodotto dall’esistere stesso, per quanto riguarda il mondo ebraico ha una colorazione particolare. Oguno è indubbiamente più sensibile a quanto colpisce i propri cari, quindi il proprio circolo di amici, e via dicendo, il proprio paese. Per il mondo ebraico però questa risonanza del dolore di un altro ebreo è molto più forte e intima. Anzi, per mia conoscenza, devo dire che persone che non si considerano ebrei pur essendolo, ma prima di tutto cittadini di un certo paese, quindi connotati con il proprio mestiere, non religiosi, si riscoprono tali allorché si parla di olocausto. Così ad esempio è stato per il filosofo ebreo russo naturalizzato francese, Wladimir Jankélévitch – allievo prediletto di Bergson – che sentì la vicinanza a quello che definì il proprio popolo solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ questo un libretto che vale la pena non tanto per quello che narra o per la strana vicenda editoriale ingarbugliata quanto perché è uno spunto originale e insolito per una riflessione su un tema sul quale sembra si sia detto così tanto, quasi troppo.
Yossl Rakover si rivolge a Dio
di Zvi Kolitz
Piccola Biblioteca 393
Adelphi Edizioni
Milano, 1997
Articolo di Ilaria Guidantoni















