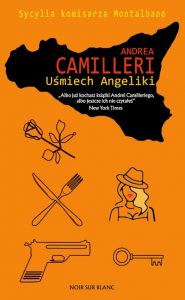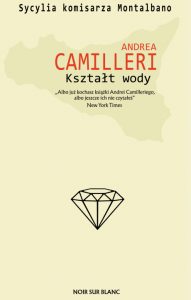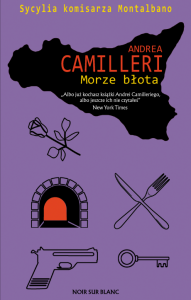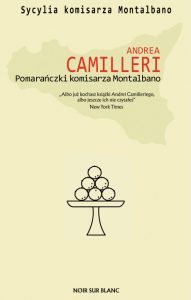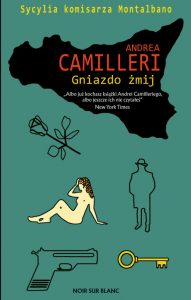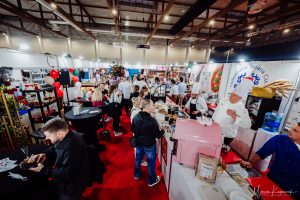Scrivo questo testo per invitare a scoprire il mondo di Andrea Camilleri sia chi non ha mai avuto tra le mani un suo libro, sia chi conosce solo il commissario Montalbano. Ma anche coloro che alla parola “giallo” storcono subito il naso e per questo motivo evitano la sua opera. È un errore, perché Camilleri è molto di più di un autore di libri polizieschi. È uno scrittore capace di raccontare con la stessa verve la quotidianità siciliana e le ossessioni culinarie, come anche la grande storia, la politica o le passioni umane. I suoi libri sono – perdonatemi la banalità – uno specchio della vita: riflettono i giorni comuni e i momenti straordinari, ora con ironia, ora con umorismo, e altre volte con tenerezza e malinconia.
Camilleri scrittore. Sì, ma questo è solo uno, e il più spettacolare, capitolo della sua strada artistica. Fu anche regista, attore, docente. Curiosamente, divenne scrittore nel senso pieno del termine, uno scrittore famosissimo, molto tardi: solo dopo i settant’anni cominciò ad avere successi letterari. Vale la pena cogliere la molteplicità dei suoi volti e dei suoi ruoli.
Andrea Camilleri è qualcuno che si può vedere come:
Creatore di un mondo straordinario: perché scriveva in un contesto tanto ricco e affascinante da sembrare a volte irreale. La sua letteratura nasceva dalla memoria e dall’esperienza della Sicilia, dalla sua lingua, cucina, costumi, ma anche dalla storia. Spesso tornava ai tempi dell’unità d’Italia, un momento burrascoso e ambiguo che aveva creato tanto l’identità dei siciliani quanto il loro senso di estraneità verso il nuovo Stato. Camilleri trasformava queste realtà in capolavori letterari al confine tra dialetto e italiano, storia e contemporaneità, quotidianità e grottesco. La sua prosa brillava di colori – gastronomia, ironia, umorismo e malinconia – come un mosaico inconfondibile.
Narratore di storie: come un vecchietto sulla piazza di Porto Empedocle che inizia con un aneddoto e finisce narrando vita e miracoli di tutto il paese.
Attento osservatore: perché, anche in tarda età, già cieco, sapeva commentare la realtà con straordinaria lucidità. Dettava nuovi libri intrecciandovi gli assurdi quotidiani, l’ironia e la tenerezza verso il mondo. Non parlava ex cathedra, piuttosto sedeva accanto al lettore, raccontandogli una storia come se lo conoscesse da sempre.
Per me è stato quello che mi ha fatto capire la Sicilia. Non ad amarla – perché quell’amore mi accompagnava da tempo – ma ad addomesticarne e comprenderne meglio la quotidianità esotica. Per spirito di contraddizione, sono felice di aver visto la parte dell’isola da lui descritta prima che nascesse la serie televisiva che rese celebre quella regione. Non conoscendo il futuro set cinematografico, mi godevo soltanto l’atmosfera dei luoghi e cercavo di collocarvi non solo i personaggi del commissario Montalbano, ma anche il farmacista Alfonso “Fofò” La Matina, Antonietta “Ntontò” Peluso de “La stagione della caccia”, o Michelino, tragico protagonista de “La presa di Macallè”.
A settembre 2025 celebriamo il centenario della nascita di Andrea Camilleri, un’ottima occasione per riflettere sulla sua opera (c’è stato anche un incontro all’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia) e ricordare una figura che occupa un posto speciale nella letteratura italiana, e soprattutto siciliana.
Mord und Pasta
Il termine “Mord und Pasta”, usato per la prima volta al festival del giallo di Monaco nel 2003, esprime perfettamente l’atmosfera della serie con il commissario Salvo Montalbano, un giallo intrecciato con la vita e la cucina siciliana. Camilleri inventò un protagonista che insegue assassini e truffatori, ma con la stessa passione va a caccia della migliore pasta, sardine o cozze, senza parlare del granchio che incontra durante le passeggiate, che tratta più come un piatto da gustare che come ascoltatore dei suoi monologhi. L’indagine non ha senso senza un buon pranzo, e il pranzo senza l’indagine non ha sapore. Proprio questa miscela – delitto e pasta, ironia e malinconia – rende i libri di Camilleri unici nel loro genere.
Camilleri scrisse ben 28 romanzi gialli con Montalbano. Non è necessario cominciare dal primo volume, ognuno è un’opera compiuta. Io consiglierei, per iniziare, i miei preferiti: La gita a Tindari, Il sorriso di Angelica, Le arance dell’ispettore Montalbano, La forma dell’acqua.
Tutti hanno in comune la figura del commissario, la galleria dei personaggi e l’atmosfera di Vigàta, città immaginaria ispirata a Porto Empedocle. Gli autori della serie TV risolsero il problema della topografia in modo geniale: “costruirono” Vigàta con più cittadine del sud-est della Sicilia – principalmente Ragusa, Modica e Scicli – e collocarono la casa del commissario nella marina di Punta Secca. Oggi lì funziona la pensione “La casa di Montalbano”, dove ci si può sentire come il protagonista di questa serie.
Il mondo di Montalbano è fatto non solo di enigmi criminali, ma anche di figure piene di vita: Livia, la fidanzata genovese di lunga data, il leale Mimì Augello, il bonario Fazio, l’inestimabile Catarella, maestro di strafalcioni linguistici, il burbero dottor Pasquano e Enzo il proprietario della trattoria in cui il commissario celebra i suoi piatti preferiti.
Lasciamo Montalbano sulla terrazza della sua casa sul mare e torniamo indietro nel tempo.
Dal cacciatore al birraio
Andrea Camilleri, oltre al ciclo di Montalbano, e forse soprattutto (sono un grande fan proprio di questa parte della sua produzione), ha lasciato una ricca collezione di romanzi storici, nei quali con straordinaria libertà univa finzione letteraria a fatti e documenti.
Uno dei primi fu La stagione della caccia, pieno di ironia e grottesco, ambientato all’inizio dell’Ottocento nella, e come poteva essere diversamente, Vigàta. Arriva in città il giovane farmacista Fois, e con lui comincia una serie di misteriose morti. È un libro a cavallo tra giallo, romanzo d’avventura e commedia di costume, leggero, divertente e insieme apripista dell’intero filone storico camilleriano.
Su un tono simile si muove La regina di Pomerania e altre storie di Vigàta, raccolta di otto racconti tra fine Ottocento e metà Novecento. Camilleri ritrae con umorismo e tenerezza la Sicilia provinciale, dai venditori di gelati, alle sedute spiritiche, alle lettere anonime che avvelenano la vita del paese.
Un altro esempio è Il nipote del Negus, romanzo-falso reportage che mescola documenti ufficiali, lettere, ritagli di giornale (lo stesso espediente che Camilleri userà ne La scomparsa di Patò) con una storia apparentemente assurda. Il tutto sembra frutto di pura fantasia. Non è così. Se l’autore dei documenti citati è un certo Camilleri, la vicenda in sé è vera e riguarda il principe Brhané Sillassié, nipote dell’imperatore Hailé Selassié I, che tra il 1929 e il 1932 frequentò la Regia Scuola Mineraria di Caltanissetta, conseguendo il diploma di perito minerario.
Un tono diverso lo offre Le pecore e il pastore, straordinario libro in cui l’autore attinge a eventi della Sicilia del 1945. La figura centrale è il vescovo Giovanni Battista Peruzzo, detto “il pastore”, che ebbe il coraggio di schierarsi dalla parte dei contadini poveri, diventando per questo bersaglio di un attentato. Mentre lotta per la vita dopo le ferite, dieci benedettine di Palma di Montechiaro compiono un sacrificio drammatico, muoiono di fame e di sete, credendo che la loro morte avrebbe salvato il vescovo. Camilleri, imbattutosi in questa storia per caso, la ricostruisce dando vita a un racconto toccante di fede, sacrificio e delle dure realtà della Sicilia del dopoguerra.
Uno dei libri più personali e amari resta La presa di Macallè, romanzo sulla guerra d’Abissinia vista con gli occhi di un bambino. Camilleri mostra come la propaganda fascista formava l’immaginario dei più giovani e come l’entusiasmo infantile si trasformasse presto in delusione e amarezza.
Macallè è uno dei miei romanzi storici preferiti di Camilleri, l’altro – immutabilmente da anni – è La rivoluzione della luna, ambientato più lontano nel tempo, nella Palermo del XVII secolo. È un racconto suggestivo di un potere femminile breve ma spettacolare. Camilleri, basandosi su un episodio realmente accaduto, disegna il ritratto di Eleonora di Mora, donna che per 27 giorni governò la Sicilia tentando di introdurre riforme giuste.
Ma Lei parla camillerese?
Uno dei più originali romanzi storici di Camilleri è Il birraio di Preston. Punto di partenza fu un fatto reale del 1874: la decisione del prefetto di Sicilia di mettere in scena in un teatro di provincia l’opera di Nicola de Giosa Il birraio di Preston. Camilleri lo trasformò in una farsa sugli assurdi della burocrazia del giovane Stato italiano.
Ma il suo esperimento più grande fu la lingua, l’autore non solo usa la caratteristica mescolanza di italiano e siciliano, ma introduce anche altri dialetti della penisola, creando un vero e proprio “teatro delle lingue” dell’Italia da poco unificata. Questo ci porta al suo segno distintivo: la lingua. Camilleri creò qualcosa di proprio, un ibrido che non era né italiano classico, né siciliano puro. È un idioma “camilleriano”, pieno di parole locali, ritmo e melodia del parlato, che i critici chiamano addirittura “il camillerese”.
Per i lettori non siciliani può risultare difficile, per i traduttori, lo so bene, inizialmente micidiale, ma nello stesso tempo conferisce ai testi (in originale) un sapore e un’autenticità irripetibili. La sua prosa suona come i racconti, le storie narrate in piazza, dove contano sia il significato delle parole sia il loro suono e la mimica del narratore.
Camilleri in Polonia
Andrea Camilleri è presente in Polonia da oltre due decenni. La sua strada verso il lettore polacco iniziò nel 2001, quando presso l’editore Noir sur Blanc uscì La forma dell’acqua, primo volume della serie con il commissario Montalbano. Da quel momento proprio Noir sur Blanc resta l’editore principale di Camilleri nel nostro Paese.
Come sottolineano Joanna Górecka e Jan Elbanowski della casa editrice: “Attualmente siamo l’unico editore polacco di Camilleri. In precedenza alcuni suoi libri sono usciti anche presso la gemella Wydawnictwo Literackie, fuori dalla serie di Montalbano, tra cui Il Tuttomio, Le pecore e il pastore il Re di Girgenti. Rebis circa dieci anni fa pubblicò Donne. Ma oggi solo Noir sur Blanc pubblica con coerenza le sue opere.”
In totale sul mercato polacco sono già disponibili 39 titoli di Camilleri: 27 romanzi della serie Montalbano e 8 altri con Noir sur Blanc (tra cui i racconti La Regina di Pomerania, La Guerra private di Samuele e altre storie, e i romanzi Il birraio di Preston, La stagione della caccia, La scomparsa di Patò), 3 con Wydawnictwo Literackie e 1 con Rebis.
Le vendite dei libri di Camilleri – ammettono gli editori – sono buone, e il numero di lettori è probabilmente aumentato dopo la messa in onda su TVP della serie sulle avventure del commissario Montalbano. “Per noi il valore sta nel fatto che i gialli di Camilleri sono completamente diversi dalla maggior parte della letteratura di questo genere in Polonia, è al tempo stesso un grande vantaggio e una sfida promozionale. Negli anni siamo riusciti a costruire un gruppo fedele di lettori e continuiamo ad ampliarlo. Le tirature e le vendite crescono gradualmente”, dice Jan Elbanowski.
Un esempio interessante di passione locale è la libreria Orbita a Rybnik, che da anni promuove con successo le avventure del commissario Montalbano. Ambasciatrice fedele di Camilleri in Polonia è anche Anna Świtajska, cofondatrice della casa editrice e della libreria di Sopot Smak Słowa, che sottolinea come lo scrittore occupi da tempo un posto speciale nella sua vita.
Come dice Anna, ne divenne un’appassionata lettrice dalle prime opere e sempre attese con impazienza ogni nuovo volume, sia i gialli di Montalbano, sia i romanzi storici. “Mi sono imbattuta in Montalbano grazie a un amico, professore di psicologia, che adorava i gialli e mi consigliò Camilleri. Da allora ho letto tutto ciò che usciva, e poi aspettavo con ansia i nuovi volumi. Durante un viaggio in Sicilia visitai i luoghi legati a Montalbano e allora compresi pienamente la follia italiana per i suoi libri e la serie TV. Anch’io amo l’adattamento televisivo, lento, suggestivo, molto ‘montalbanesco’. Nello Smak Słowa incontro molti appassionati simili, lettori che ogni anno attendono un nuovo volume, alcuni guardano la serie, altri vanno in Sicilia in cerca della trattoria di Enzo.”
E poi?
I piani editoriali di Noir sur Blanc comprendono sia i prossimi volumi di Montalbano, fino alla conclusione della serie, sia libri fuori dal ciclo. Sono in preparazione tra gli altri Noli me tangere e Rivoluzione della luna.
Pirandello scriveva che ognuno di noi ha centomila facce. Camilleri ha mostrato che anche la Sicilia si può raccontare in centomila modi, una volta sul serio, un’altra non tanto, una volta attraverso la cucina, un’altra attraverso il delitto.
Camilleri, scrittore amatissimo, e, come diceva lui stesso, scelto democraticamente dai lettori, sarà sempre con noi, in persona, anche se non, come diceva il assistente Catarella, personalmente.

Maciej A. Brzozowski, italianista (laureato in Filologia Italiana all’Università di Varsavia), traduttore di letteratura, pubblicista (“Twój STYL”, “Pani”), autore dei libri “Gli italiani, la vita è teatro” (Muza), “Divine. Le italiane che hanno sedotto il mondo” e del più recente: “Uccelli del paradiso. Gli italiani che hanno conquistato il mondo” (entrambi pubblicati da Znak Horyzont).