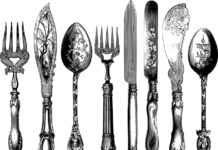«Essendosi principiato de seminare del rixo nel ducato di quella nostra città, et non trovandosi persona che lo sapesse conciare et redurre alla perfectione sua, hanno facto venire de Savona doi maestri apti», questo scrive Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, il 9 dicembre 1473. Ci fa così sapere che nei dintorni della città si coltivava il riso, ma che ancora non c’era personale specializzato in grado di pilarlo e quindi se ne può dedurre che la coltivazione era stata introdotta da poco.
Qualche tempo prima, nel 1468, c’erano risaie attorno a Pisa e un tal Leonardo Colto de’ Colti chiede alla signoria dei Medici – a Firenze regnava Lorenzo il Magnifico – l’autorizzazione ad allargare l’utilizzo della nuova semente ad altri appezzamenti in Toscana. Sappiamo da una lettera del 1548, che nella corte di Cosimo I de’ Medici si mangiava questo cereale.
Sull’origine del riso non ci sono dubbi: è il cereale autoctono dell’oriente asiatico, in contrapposizione al grano, cereale autoctono dell’occidente europeo. Ancor oggi la Cina consuma riso e non pane. Il medico romano Galeno lo indica come medicinale, il suo mondo conosce il riso, gli dà nome oryza, ma lo tratta come una ghiottoneria riservata ai più ricchi. I romani lo commerciano importandolo dall’oriente, ma non lo coltivano.
Sono gli arabi a portarlo in Europa, in Spagna, nella zona di Valencia, dove avevano creato uno splendido sistema di canali. Gli spagnoli cominciano a usarlo cotto in bianco per accompagnare il pesce, in sostituzione del cuscus, gli altri popoli mediterranei preferiranno metterlo nelle minestre.
Il riso e la farina di riso costituivano l’ingrediente di base per ispessire una delle minestre più diffuse del medioevo: il biancomangiare. Il nome deriva dal fatto che si trattava di un alimento candido ed era apprezzato proprio per questo, il colore prevaleva sul sapore. Il nitore era ottenuto grazie al riso, si cucinava con brodo e carne di cappone, ma ne esisteva pure una versione quaresimale, ottenuta con un qualche pesce dalla carne bianca.
 In uno dei grandi bacini risicoli della gastronomia italiana, l’entroterra di Venezia, si distingueva tra le minestre di riso (risi e bisi è la più celebre) e risotti (risotto di pesce). Il metodo di cottura era diverso: nelle minestre si mettevano assieme fin dall’inizio brodo (o acqua) e riso, nei risotti il brodo si aggiungeva man mano. Bisogna essere molto più esperti per preparare una minestra perché è necessario sapere esattamente quanto brodo sia necessario per una data quantità di riso, al fine di ottenere una minestra della consistenza voluta. Se il rapporto non è giusto vien fuori una brodaglia. Il risotto, invece, perdona gli errori: basta aggiungere un po’ più o un po’ meno brodo durante la cottura per arrivare alla densità desiderata. Questo è il motivo per cui, ormai, le minestre di riso non le fa quasi più nessuno.
In uno dei grandi bacini risicoli della gastronomia italiana, l’entroterra di Venezia, si distingueva tra le minestre di riso (risi e bisi è la più celebre) e risotti (risotto di pesce). Il metodo di cottura era diverso: nelle minestre si mettevano assieme fin dall’inizio brodo (o acqua) e riso, nei risotti il brodo si aggiungeva man mano. Bisogna essere molto più esperti per preparare una minestra perché è necessario sapere esattamente quanto brodo sia necessario per una data quantità di riso, al fine di ottenere una minestra della consistenza voluta. Se il rapporto non è giusto vien fuori una brodaglia. Il risotto, invece, perdona gli errori: basta aggiungere un po’ più o un po’ meno brodo durante la cottura per arrivare alla densità desiderata. Questo è il motivo per cui, ormai, le minestre di riso non le fa quasi più nessuno.
Dagli ultimi decenni dell’Ottocento a metà Novecento, fino a quando non sono state sostituite da pesticidi e macchine agricole, decine di migliaia di donne (fino a 100.000), per quaranta giorni, dai primi di giugno a metà luglio, convergevano nelle zone di coltivazione del riso. Erano povere donne di ogni età, dalle bambine alle cinquantenni, arrivavano soprattutto da Piemonte, Lombardia e Veneto, ma anche da tutto il resto d’Italia, comprese le regioni meridionali. Dovevano prima trapiantare le pianticelle di riso (al tempo non si seminava direttamente nelle risaie, come oggi) e poi mondare (da cui mondine) i campi dalle erbacce. Il lavoro era durissimo, sfibrante. L’epopea delle mondine è stata immortalata in un film al tempo famosissimo, Riso Amaro, uscito nel 1949, con la regia di Giuseppe De Santis, uno dei massimi esponenti del neorealismo italiano. L’interprete femminile è una ragazza di 19 anni, fino ad allora sconosciuta, Silvana Mangano. Le parti maschili vanno ai due «belli» del cinema di quegli anni: Raf Vallone e Vittorio Gassman. Il film ha un successo straordinario e impone la Mangano come una delle sexy super maggiorate, assieme a Sofia Loren e Gina Lollobrigida, simboli della bellezza femminile italiana.
La Lombardia diffonde nell’Italia settentrionale sia il riso, sia il risotto. Quello alla certosina era il nutrimento dei monaci della certosa di Pavia nei giorni di magro. I rigidi monaci certosini ammettevano gli animali poveri, quelli derivati da catture spontanee, né cacciati né allevati, e quindi preparavano il risotto con con gamberi di fiume, rane e lumache.
 Il risotto alla milanese, invece, è una preparazione di origine aristocratica. Lo indica l’abbinamento con l’ossobuco, lo dimostrano i suoi ingredienti: il midollo di bue e, soprattutto lo zafferano. Questa spezia che colora gli alimenti di giallo, simboleggia l’oro, qualcuno sostiene che abbia avuto più successo per il colore che per il sapore. Tra medioevo e prima età moderna, quando la gastronomia era soprattutto coreografia, non era così inconsueto ornare gli alimenti con foglie d’oro. Ma chi non poteva permettersi il metallo giallo, suppliva con la spezia gialla. Il cerchio simbolicamente si chiude quando Gualtiero Marchesi, celebre chef milanese, ha cominciato a servire nel suo locale il risotto con foglia d’oro.
Il risotto alla milanese, invece, è una preparazione di origine aristocratica. Lo indica l’abbinamento con l’ossobuco, lo dimostrano i suoi ingredienti: il midollo di bue e, soprattutto lo zafferano. Questa spezia che colora gli alimenti di giallo, simboleggia l’oro, qualcuno sostiene che abbia avuto più successo per il colore che per il sapore. Tra medioevo e prima età moderna, quando la gastronomia era soprattutto coreografia, non era così inconsueto ornare gli alimenti con foglie d’oro. Ma chi non poteva permettersi il metallo giallo, suppliva con la spezia gialla. Il cerchio simbolicamente si chiude quando Gualtiero Marchesi, celebre chef milanese, ha cominciato a servire nel suo locale il risotto con foglia d’oro.
Il veneziano Carlo Goldoni nomina il riso in alcune delle sue commedie. Per esempio i non meglio identificati «gran risi» ne I Morbinosi oppure i «cento risi co la quagietta» che propone l’oste di Chi la fa l’aspetta. Si tratta di un risotto di caccia, uno dei tanti piatti di risi della cucina veneziana. La tecnica di preparazione era quella tipica di questi piatti: si partiva da un fondo caratterizzato dalla presenza di carne di quaglia, ottenuta arrostendo i
piccoli volatili con con fettine di pancetta, salvia e rosmarino e utilizzando per il fondo solo le polpine, poi si univa il riso e lo si portava a cottura e lo si porzionava nei piatti ponendovi sopra una quaglia intera col sugo di cottura.» Nel Sior Todaro Brontolon, il taccagnissimo protagonista dell’omonima commedia, fa stracuocere il riso per fare più parte.
Una ricetta del tutto simile a quella attuale del risotto milanese si trova invece nel libro che Giovanni Felice Luraschi pubblica nel 1853. Risotto alla milanese giallo, lo chiama e prevede soffritto di cipolla, burro e midollo, poi si mette il riso, si aggiungono zafferano e noce moscata, a metà cottura si aggiunge una salsiccia e alla fine formaggio grattugiato. La ricetta successiva, riso all’italiana, prevede di fare «come sopra, ma senza zafferano, perché rimanghi bianco.»
 I piselli avevano una lunga tradizione di cibo aristocratico, da quando Colombano, il santo irlandese abate di Bobbio (Piacenza), fa crescere piselli fra gli aridi dirupi dell’Appennino. Il comasco Mastro Martino riporta una ricetta di «piselli fricti in carne salata», una sorta di archetipo dei piselli al prosciutto, e poi la moda passa in Francia, dove i piselli godono di un crescente prestigio, tanto che la corte del re Sole impazzisce per il legume verde. «Ci sono dame che dopo aver cenato col re, e bene, si fanno preparare a casa dei piselli per mangiarli prima di andare a dormire, a rischio di indigestione. È una moda, è un furore.» Niente di strano, quindi, che arrivino piselli sulla tavola del doge di Venezia, i risi e bisi del giorno di San Marco.
I piselli avevano una lunga tradizione di cibo aristocratico, da quando Colombano, il santo irlandese abate di Bobbio (Piacenza), fa crescere piselli fra gli aridi dirupi dell’Appennino. Il comasco Mastro Martino riporta una ricetta di «piselli fricti in carne salata», una sorta di archetipo dei piselli al prosciutto, e poi la moda passa in Francia, dove i piselli godono di un crescente prestigio, tanto che la corte del re Sole impazzisce per il legume verde. «Ci sono dame che dopo aver cenato col re, e bene, si fanno preparare a casa dei piselli per mangiarli prima di andare a dormire, a rischio di indigestione. È una moda, è un furore.» Niente di strano, quindi, che arrivino piselli sulla tavola del doge di Venezia, i risi e bisi del giorno di San Marco.
***

Pillole culinarie è una rubrica di approfondimento sulla storia della cucina curata dal giornalista e scrittore Alessandro Marzo Magno. Dopo essere stato per quasi un decennio il responsabile degli esteri di un settimanale nazionale, si è dedicato alla scrittura di libri di divulgazione storica. Ne ha pubblicati diciassette, uno di questi “Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo” ripercorre la storia delle più importanti specialità gastronomiche italiane.