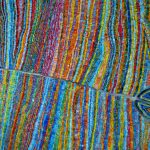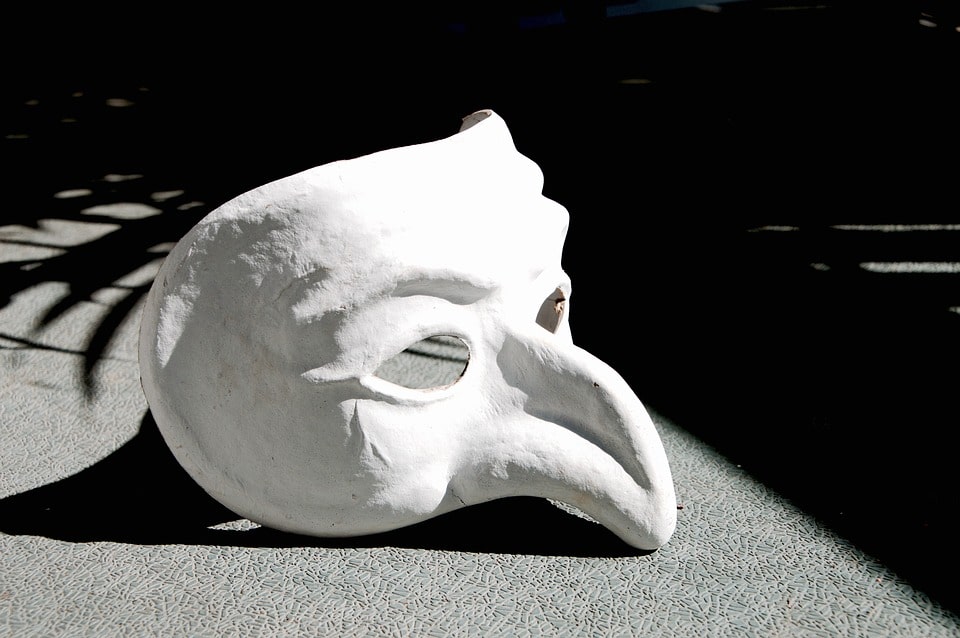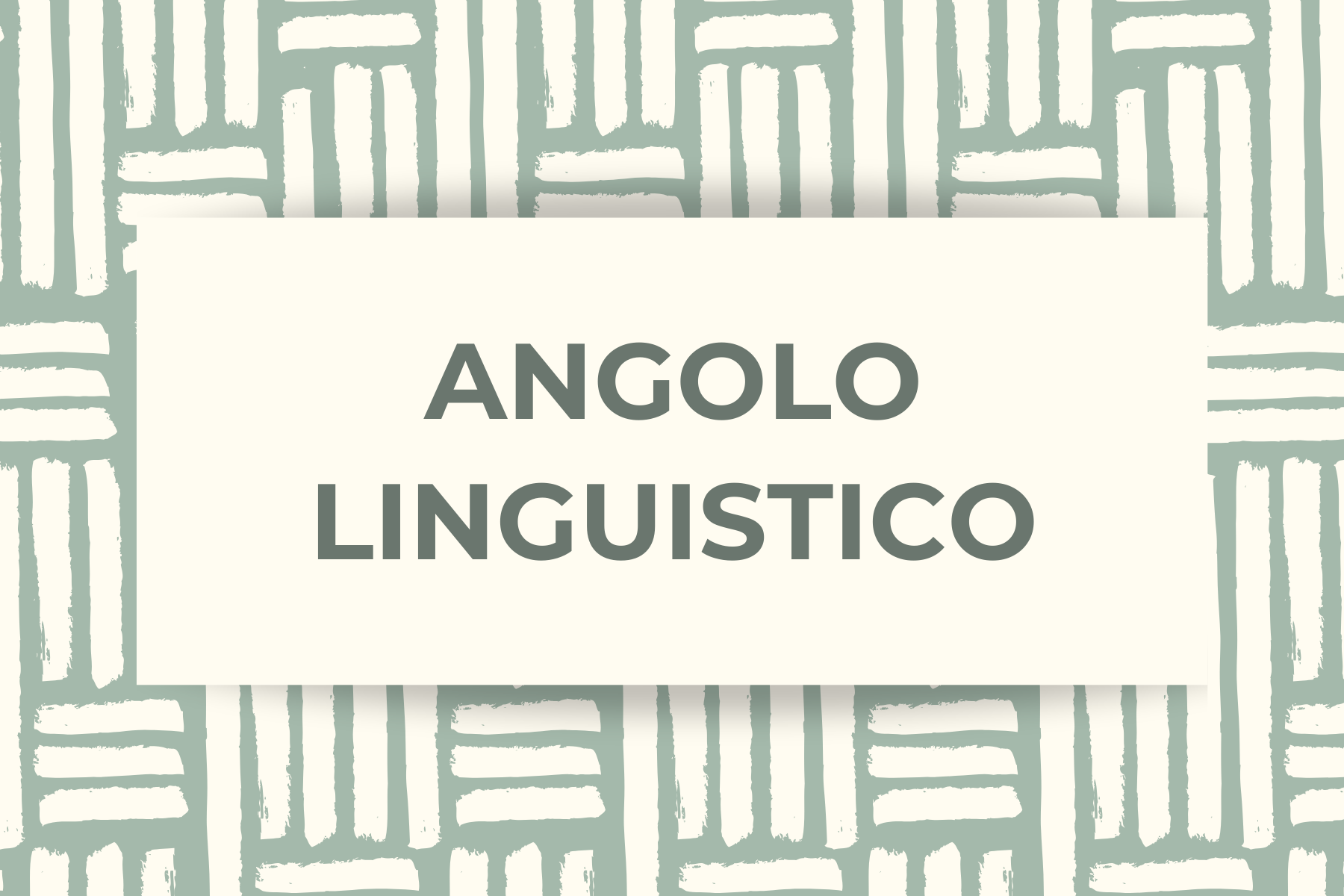Postarajmy się znaleźć odpowiedzi na następujące zagadki i ciekawostki językowe:
Pisze się qual è czy qual’è?
Jest to błąd często popełniany również przez wielu Włochów. Absolutnie BEZ apostrofu. Piszemy qual è i to z bardzo prostego powodu. W tym przypadku wypadnięcie ostatniej samogłoski wyrazu „quale” spowodowane jest apokopą (zanikiem głoski w wygłosie), a nie elizją (opuszczeniem wygłosowej samogłoski lub końcowej sylaby wyrazu przed samogłoską nagłosową następnego wyrazu – przyp. tłum.).
Pisze się un po’ czy un pò?
Również i to jest dość powszechny błąd. Piszemy un po’, z apostrofem. Po’ to skrót wyrazu poco (mało). Ktoś mógłby teraz zauważyć, że dopiero co powiedzieliśmy (w przypadku quale), że gdy dokonujemy skrótów, nie stosujemy apostrofu. Cóż, chodzi tu o wyjątek…
Jak pisać – łącznie czy oddzielnie?
Podajmy przykłady wyrażeń lub słów pisanych łącznie i tych zapisywanych oddzielnie. Chodzi tu o wyrazy często bardzo trudne do przetłumaczenia na język polski (dlatego też nie podajemy tutaj żadnych ekwiwalentów polskich – w dużej mierze zależą one od kontekstu, w którym dany wyraz został użyty). Źródłem poniższej listy jest strona Accademii Della Crusca.
Piszemy oddzielnie:
a fianco, a meno che, a posto, a proposito, al di là, al di sopra, al disopra, al di sotto, al disotto, all’incirca, d’accordo, d’altronde, in quanto, l’altr’anno, per cui, poc’anzi, quant’altro, senz’altro, tra l’altro, tutt’altro, tutt’e due, tutt’oggi, tutt’uno
Piszemy łącznie:
a fianco, a meno che, a posto, a proposito, al di là, al di sopra, al disopra, al di sotto, al disotto, all’incirca, d’accordo, d’altronde, in quanto, l’altr’anno, per cui, poc’anzi, quant’altro, senz’altro, tra l’altro, tutt’altro, tutt’e due, tutt’oggi, tutt’uno
Wyrażenia z kolorem rosso (czerwonym):
- Rosso di sera, buon tempo si spera. (dosł. Czerwony wieczór daje nadzieję na dobrą pogodę.) Jest to przysłowie wyrażające dobre życzenie. Na ogół jeśli podczas zachodu słońca możemy zaobserwować na niebie głównie kolor czerwony, mówimy, że kolejny dzień będzie piękny i słoneczny.
- Un film a luci rosse. (dosł. Film „o czerwonych światłach”.) – mówimy tak o filmie z podtekstem erotycznym.
- Diventare rosso (come un peperone). (dosł. Stać się czerwonym jak papryka.) Kiedy czerwienimy się ze wstydu lub złości, również gdy (podczas opalania) spalimy się na słońcu.
- Il mio conto è in rosso. (dosł. Moje konto jest czerwone.) Mam na koncie debet.
- Avere gli occhi rossi. (dosł. Mieć czerwone oczy.) W następstwie płaczu.
- Vedere rosso. (dosł. Widzieć na czerwono.) Odczuwać wściekłość.
- Le camice rosse. (dosł. Czerwone koszule.) Historycznie – garibaldczycy, osoby walczące u boku Garibaldiego.
- Essere bianco e rosso. (dosł. Być biało-czerwonym.) Cieszyć się dobrym zdrowiem.
Wyrażenia i przysłowia ze słowem gatto (kot):
- Essere agili come un gatto. (dosł. Być zręcznym/zwinnym jak kot.) Kot to zwierzę potrafiące wszędzie wskoczyć i wszędzie się wdrapać.
- Essere come il gatto e l’acqua bollita. (dosł. Być jak kot i wrząca woda.) Za nic się nie zgadzać, nie dogadywać, odczuwać wobec siebie antypatię i niedopasowanie. Wyrażenia tego można również użyć w celu podkreślenia czyjegoś lęku przed czymś (koty bardzo boją się wody, a co dopiero wrzącej!).
- Essere come il gatto e la volpe. (dosł. Być jak kot i lis.) Gdy mowa o dwóch indywiduach wzajemnie sobie pomagających w dokonywaniu czegoś nieuczciwego.
- Essere quattro gatti. (dosł. Być czterema kotami.) Być w marnej liczbie, na przykład: alla riunione eravamo in quattro gatti. (= podczas spotkania byliśmy [jedynie] we czwórkę.)