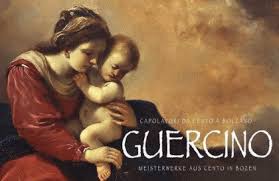Spesso passiamo le nostre vacanze sulla riviera adriatica. Un pò più a nord, un pò più a sud, ma malvolentieri ci spingiamo lontano dalla costa.
Venezia? Oh si, lì bisogna andare, lì si deve andare, è una tappa obbligata, così parlando con gli amici possiamo vantarci di quanto abbiamo pagato per un caffé al Caffé Florian o al Caffé Quadri in Piazza San Marco, e di chi abbiamo incontrato all’Harry’s Bar, di come nonostante gli avvertimenti nostro marito sia passato in mezzo a due colonne, e di quanti di noi sono stati imbrogliati da un gondoliere veneziano.
Di certo tutti andiamo a San Marino (anche se ultimamente ho letto che il numero di turisti polacchi è calato drasticamente), perchè bisogna comprare liquori, vini e cosmetici a basso prezzo.
Dove altro andiamo? Cos’altro visitare sulla costa adriatica?
Forse Ravenna, ma pochi sanno che ai tempi di Ottaviano Augusto era il porto marittimo più importante della regione. E nessuno ricorda che per 200 anni è stata la capitale dell’Impero Bizantino in Italia.
E così finiscono le visite durante le due settimane di ferie.
Vi incoraggerò ad essere turisti più attivi. Vi mostrerò quante cose si possono vedere durante una vacanza di due settimane sull’Adriatico, senza stare ad arrostirsi sulla spiaggia.
Bologna, Padova, Urbino, Modena, Maranello e il Museo della Ferrari, San Leo, Bertinoro, Verona, il Lago di Garda, Cesenatico, Trento (capitale mondiale della pallavolo) e naturalmente l’Italia in Miniatura, paradiso per i bambini di tutte le età e anche per i genitori. Magari non in un solo soggiorno, magari pianificando bene il percorso, ma visitare queste città sarà divertente e vi lascerà dei ricordi indimenticabili.
A 60-70 Km di distanza a sud-ovest di Rimini, e delle altre cittadine turistiche nei dintorni, si trova Urbino, la città intera è sotto particolare cura dell’UNESCO ed è inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità. Questa città che ha dato i natali a Raffaello Sanzio e a Valentino Rossi.
Arrivando in città (da Pesaro, insieme alla quale Urbino è capitale di provincia nelle Marche), o in occasione di una gita a San Leo (da San Leo a Urbino ci sono 57 km di viaggio attraverso strade di campagna tortuose e pittoresche dove si possono osservare i “veri” paesaggi italiani lontani dalle autostrade, un paradiso per i fotografi), è possibile percepire l’importanza e la forza di questa città, osservando l’imponente Palazzo Ducale.
Informazioni utili:
1. Ci sono due parcheggi per le automobili (superiore e inferiore). Il parcheggio inferiore, che si trova in prossimità del Palazzo Ducale è molto spazioso e pratico, lì troverete sempre un posto.
2. Entrambi i parcheggi sono a pagamento, qualche euro per 3-5 ore. Se volete essere sicuri comprate un biglietto al massimo di 6 ore. Vi basteranno per visitare Urbino, bere il caffè in una caffetteria e pranzare.
3. La polizia controllerà le ore che avete pagato al parcheggio! Potreste restare spiacevolmente sorpresi di trovare una multa appena qualche minuto dopo la fine del vostro biglietto. Non pensate neanche di buttarlo e non pagare! Vi troveranno nel giro di sei mesi e il costo da 30 euro salirà a 400. È per questo che al commissariato accanto al parcheggio inferiore c’era una gran fila. Sono convinto che dopo qualche ora passata ad Urbino, aspettare almeno un’ora in fila davanti al commissariato sarà una cosa che ricorderete a lungo, e di questa bellissima città non resterà un bel ricordo.
4. Dal parcheggio inferiore al Palazzo Ducale c’è un ascensore (si trova all’angolo del parcheggio) si paga circa 50 centesimi. Ci risparmia almeno un’ora se vogliamo andare dal parcheggio inferiore a quello superiore.
Non so dove sia il centro di Urbino, ma tutta la città si può visitare nel giro di qualche ora fermandosi qua e là in qualche caffetteria.
Per me il centro della città è Piazza della Repubblica, una piccola piazza chiassosa piena di caffetterie e probabilmente il luogo di incontro preferito per giovani studenti. Siamo arrivati lì l’ultimo giorno dell’anno accademico, da qui il chiasso e l’allegria, soprattutto di coloro che si erano appena laureati. Ma le ragazze con la corona d’alloro sulla testa, simbolo della laurea appena ricevuta, costituivano una ulteriore attrattiva della città.
Esiste una tipica passeggiata turistica che parte da Piazza della Repubblica e si arrampica su verso Via Raffaello Sanzio. Qui al numero 57 è nato il grande pittore del Rinascimento, il rivale di Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio. Oggi c’è un museo. Questa strada termina col monumento di Raffaello e con i busti dei più importanti professori dell’università di Urbino. Da lì si può ammirare un bellissimo panorama sull’Appennino Umbro-Marchigiano, ai cui piedi è situata la città.
Da una strada di fronte Piazza della Repubblica arriviamo dietro il Palazzo Ducale, dove si trova la Galleria Nazionale della Regione Marche, con la sua collezione che comprende opere di Botticelli, Donato Bramante, Piero della Francesca. Entriamo nella grande piazza dove si trova la Cattedrale di San Francesco.
Passeggiando lungo le stradine strette e tortuose di Urbino, vale la pena di alzare la testa e osservare. Il coronamento di questa visita dovrebbe essere un ricco pasto. Consiglio il ristorante Dolce Vita in Piazza della Repubblica, o 50 metri più avanti in Via Raffaello Sanzio a destra il ristorante Il Girarrosto (buonissimo e fresco cibo italiano, che dev’essere consacrato dal mascarpone come dessert).
Non sono sceso di proposito nei dettagli. È tutto sulle guide. Volevo soltanto incoraggiarvi a visitare questa città.
Siete tutti invitati ad Urbino, la città di Raffaello Sanzio.
Per finire suggerisco un breve video (purtroppo girato con un telefono cellulare): http://www.youtube.com/watch?v=uZGHYQ1ojn8