Marco Polo forever! Con il numero 103 iniziamo il 14° anno di Gazzetta col botto! Marco Polo blogger in copertina e all’interno un approfondimento dello storico Pier Alvise Zorzi, dedicato al più famoso dei viaggiatori a 700 anni dalla sua morte, ed un articolo che sottolinea la differenza culturale tra il comportarsi da viaggiatori o da turisti quando si viaggia. Ancora una volta Gazzetta vi sorprenderà offrendovi interviste con lo scenografo italiano Luigi Scoglio che lavora a Lodz, articoli sull’inventore degli spaghetti western Sergio Leone, e poi ancora raccontiamo il poco noto viaggio di Maria Sklodowski Curie in Italia, e ancora articoli su Palermo, Vercelli, l’approfondimento linguistico del professor Tucciarelli sulle comunanze linguistiche tra italiano e polacco e poi naturalmente tutte le nostre rubriche. Questo e tanto altro nel numero 103 e quindi volate negli Empik a prendere la vostra copia di Gazzetta Italia!
Apple pie
Per la base:
225 g di burro freddo
450 g di farina 00
100 ml di acqua ghiacciata
1 pizzico di sale
Per il ripieno:
1 kg di mele renette già pulite
100 g di zucchero
1 limone
2 cucchiai di acqua
1 cucchiaino di cannella in polvere
1 pizzico di noce moscata
Qualche noce di burro
Latte intero per spennellare
Per guarnire:
200 g di panna fresca da montare
1 cucchiaio di zucchero semolato
2 pizzichi di cannella
Procedimento:
In planetaria o in una grande ciotola se lavorate a mano, mettete il burro freddo a pezzetti con la farina e un pizzico di sale e iniziate ad impastare. Aggiungete poco per volta l’acqua ghiacciata e continuate a lavorare l’impasto prima in planetaria e poi a mano, su un piano infarinato, per circa 10 minuti, fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Coprite con pellicola e mettetelo a riposare a temperatura ambiente per circa 20 minuti. Nel frattempo occupatevi delle mele. Pulitele, sbucciatele e riducetele in quarti. Ricavatene poi delle fettine da circa 5 mm di spessore. Mettetele in ammollo in acqua fredda e succo di limone per evitare che anneriscano. In una padella antiaderente con fondo doppio mettete lo zucchero, la cannella e la noce moscata, fate sciogliere a fuoco lento, aggiungendo due cucchiai di acqua. Aggiungete anche una noce di burro morbido. Unite poi le mele a pezzetti e cuocetele per circa 5 minuti, finché non risultino croccanti fuori e morbide dentro. Fate intiepidire. Riprendete la pasta e dividetela in due parti, una più grande dell’altra. Stendetela con il matterello su un piano infarinato e ricavate una sfoglia dello spessore di 4 mm.
Stendetela dentro una tortiera dai bordi scanalati (tipica dell’Apple pie americana) imburrata, e fate aderire bene la pasta al fondo e ai bordi.
Versate le mele tiepide, tenendo la parte centrale del ripieno più alto e abbondante, per dare la classica forma della torta americana, arricchite il ripieno con qualche fiocco di burro morbido.
Stendete anche l’altro pezzo di pasta e coprite il ripieno. Tagliate con un coltello affilato l’impasto in eccedenza e unite sui bordi i due strati di pasta pizzicandoli con le dita.
Incidete il “coperchio” di pasta con piccoli tagli a raggiera. Spennellate la superficie con il latte.
Cuocete a 200° in forno statico per 20 minuti, spennellate di nuovo con il latte e infornate nuovamente abbassando la temperatura a 180° per circa 20 minuti, poi spennellate di nuovo e cuocete a 170° per gli ultimi 20 minuti. Spegnete il forno e fate raffreddare la torta all’interno.
Servite direttamente dentro l’apposita tortiera accompagnando la fetta di torta con panna leggermente montata aromatizzata con zucchero e cannella.
Papalina, pennette uovo e zucchine
Ci sono molte storie su questa pasta, la più antica è quella secondo cui nel 1796, durante la campagna di Napoleone in Italia, alcuni generali francesi furono accolti in Vaticano. Fu offerto loro di mangiare con il Papa Pio VI, ma visto che i francesi non gradivano la carne lo chef papale propose una pasta a base di uova e zucchine. Ci sono altre storie legate a questa ricetta, una risale al 1933 quando un oste romano realizzò questa pasta per il futuro Papa Clemente Pio XII che non voleva mangiare la già “famosa” Carbonara perchè troppo pesante e poco raffinata. Si può dire che è un piatto saporito ma delicato e indubbiamente aristocratico.
Per cortesia non chiamatela carbonara di zucchine, di carbonara ce n’è una sola!
Ingredienti della mia versione per 2 persone:
200 g di pennette rigate
2 tuorli grandi
300 g di zucchine
1 cipolla piccola
50 g provola o parmigiano
Origano, pepe nero, olio evo, burro, q.b.
Preparazione:
Tagliare la cipolla molto sottile e brasarla dolcemente in una padella con un po’ d’olio evo e burro, mettere da parte. Tagliare le zucchine a rondelle di ca. 4 mm metterle su una padella con un po’ d’olio evo e cuocere a fuoco vivace, 2-3 minuti prima della fine cottura aggiungere l’origano e il sale, mettere da parte. Nel frattempo mettete a bollire l’acqua, salate e versate la pasta. Mettete in una ciotola i tuorli d’uovo, un pizzico di sale, il pepe a piacere e la provola o parmigiano grattugiati. Mescolare energicamente per ottenere una crema, aggiungendo un po’ di acqua di cottura della pasta. Unire la cipolla nella padella delle zucchine, accendete il fuoco molto basso, solo per intiepidire, quando la pasta sarà pronta, scolatela e mettetela nella padella con le zucchine e cipolla, mescolate delicatamente e di seguito unite la salsa d’uovo, amalgamare bene senza scaldare troppo l’uovo, impiattare, aggiungete ancora un po’ di provola grattugiata e servite.
Buon Appetito!
Venezia, il Vino e il Vetro: Una degustazione emozionale attraverso la grande pittura rinascimentale
La storia della Serenissima si interseca in modo indissolubile con le culture del vino e del vetro tra vicissitudini, conquiste e commerci preziosi. Ripercorriamo le tappe di questo legame profondo, celebrandolo con un evento tra gusto, arte e bellezza nel contesto di The Venice Glass Week 2023 di cui Nexa Event&Travel Designers è partner ufficiale.
La location prescelta è un Palazzo del 1200 con affaccio sul Canal Grande; anticamente “fondaco”, luogo in cui i mercanti forestieri depositavano le loro merci e esercitavano i loro traffici. Il palazzo ospita ora il The Venice Venice Hotel dove ogni spazio, in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, è testimone delle tendenze più rimarchevoli nel campo dell’arte contemporanea internazionale.
Alla luce soffusa delle candele di questa cornice storica dal gusto irriverente, Nicola Sabbatini, mentore d’eccezione, cultore del vino e sommelier, ci guida in un viaggio seducente ripercorrendo la storia del vino e le trasparenze dei suoi contenitori in vetro.
Tra il 1200 e il 1700 Venezia è il più grande mercato del vino nel mondo.
La scintilla che accende l’avventura risale agli eventi della IV crociata in cui la valenza religiosa si trasforma ben presto in sete di conquista. L’obiettivo è Costantinopoli, capitale del ricchissimo impero romano-bizantino. Venezia guida la conquista di Costantinopoli, acquista crediti nei confronti dei crociati, ed è ricompensata con isole e territori della Grecia.
In Grecia, a Monemvasia (in greco “porto con una sola uscita”) parola in seguito storpiata dai veneziani in “Malvasia”, viene scoperto un vino dolce, intenso, pregiato e adatto al trasporto via mare. Da quel momento tutti i vini che arrivano a Venezia e provengono dall’Oriente, sono chiamati Malvasie; sono vini leggendari, legati a storie affascinati, pregiati, ricercati e costosi. Diventano l’oro liquido della Serenissima. Venezia è capitale mondiale del vino, ed esporta il nettare “navigato” nelle corti di tutta Europa.
Contemporaneamente, e sempre a seguito dei commerci con l’Oriente, Venezia è una delle poche città in cui si fa uso del vetro sulle tavole della nobiltà mercantile. Nell’isola di Murano, a partire dal 1300, si cominciano a produrre manufatti in vetro. Ma è a seguito del lavoro di Angelo Barovier, nella seconda metà del ‘400, che il vetro, reso non solo trasparente, ma addirittura cristallino, diventa di moda sulle tavole dei ricchi commercianti veneziani.

Questo mutamento si nota nei dipinti della scuola veneziana del 1500; d’un tratto è possibile ammirare il colore, la trasparenza e la luminosità del vino attraverso i calici cristallini di squisita fattura, prodotti a Murano. A testimonianza di quanto ormai sia di moda il vetro nelle tavole e nei banchetti del Rinascimento, troviamo i calici trasparenti nella Cena in Emmaus del Tiziano, nel Convito in Casa Levi del Veronese, nell’Ultima Cena del Tintoretto, e anche Caravaggio, (sul finire del secolo) nel suo celebre Bacco, dipinge una squisita coppa troncoconica, di chiara fattura veneziana. Questo significa che anche a Roma, dove il Caravaggio all’epoca operava, si degusta “alla moda di Venezia”.
Attraverso i dipinti di questi grandi maestri abbiamo intrapreso un percorso inesplorato, con la degustazione di quattro vini provenienti da cantine d’eccezione. Il percorso, fluido ed emozionale, è iniziato con il Durello dei Monti Lessini Borgo Rocca Sveva, proseguendo con il Malvasia Venica&Venica e il Venusa Venissa, per concludersi con il Raboso del Castello di Roncade. Durante la narrazione, abbiamo gustato i signature bites della cucina, ispirati alla tradizione veneziana con un twist innovativo: sposalizio perfetto.
Un’esperienza unica, divertente e utile, un evento lungo un tramonto, che, quasi come un sogno, è svanito quando le ultime luci del giorno hanno lasciato spazio alla notte.

I falsi amici della dieta
In linguistica, i falsi amici sono le parole o le espressioni che, in due differenti lingue, appaiono quasi uguali per grafia o pronuncia, ma a dispetto di ciò hanno un significato molto diverso. Termini ingannevoli, fonte di malintesi e momenti più o meno imbarazzanti, presenti anche tra italiano e polacco. Qualche esempio a tema alimentazione?
Il termine italiano panna in polacco significa signorina. Presente in entrambe le lingue anche la parola cena, solo che in polacco ha il significato di prezzo, mentre il pasto serale si traduce con kolacja, a sua volta simile al nostro colazione che si traduce invece con śniadanie.
Anche nell’alimentazione ci possono essere molti falsi amici. Si tratta di quei cibi che siamo convinti che facciano bene e magari che facciano anche dimagrire, mentre al contrario sono poco salutari o comunque sono ipercalorici e per niente dietetici. Ma da dove arrivano le nostre convinzioni errate? A volte da luoghi comuni, da leggende metropolitane, ma il più delle volte da efficaci strategie di marketing che fanno leva sul desiderio più diffuso: quello di stare bene ed essere magri. Questi falsi amici dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che è necessario imparare ad acquistare e mangiare con maggiore consapevolezza.
Cominciamo dalla colazione: granola, muesli, corn flakes. Li chiamiamo comunemente cereali, ma spesso contengono davvero molti, troppi zuccheri semplici, grassi e conservanti. Nel migliore dei casi gli eccessi derivano da frutta secca e disidratata, ma il più delle volte sono arricchiti da zuccheri aggiunti (presenti anche come sciroppo di riso o di glucosio) per rendere il prodotto più goloso. Al loro posto si possono scegliere dei cereali soffiati: ad esempio riso, farro, miglio, grano saraceno. Volendo aggiungere una nota croccante e golosa, la colazione può essere arricchita da frutta secca oleosa in quantità adatta al proprio fabbisogno calorico, e scaglie di cioccolato fondente con alta percentuale di cacao.

Ma la frutta disidratata non è salutare? Se non ci sono zuccheri aggiunti, in effetti lo è, ma è anche ipercalorica. A pari quantità di alimento, ad esempio, le albicocche disidratate apportano 5 volte più calorie rispetto a quelle fresche, e sono prive di vitamine e ovviamente di acqua, quindi non danno senso di sazietà. Avremo la sensazione di aver fatto una merenda sana, e dopo un’ora avremo fame più di prima.
Anche centrifughe ed estratti non possono essere considerati un buon sostituto della frutta fresca, e andrebbero consumati con moderazione. Anche senza l’aggiunta di edulcoranti, il succo 100% frutta contiene tutti gli zuccheri dei frutti da cui è ricavato: in media, una porzione di 200 ml contiene 24 grammi di zucchero, pari a 6 bustine in un solo bicchiere! La frutta fresca inoltre è ricca di fibre, che nutre il microbiota intestinale, e ci costringe alla masticazione che induce il senso di sazietà.
Sempre per quanto riguarda colazione e merenda, anche lo yogurt può essere un falso amico. Considerato l’alimento sano per eccellenza, uno yogurt alla frutta può contenere anche 13 grammi di zucchero (più di 3 bustine). La soluzione è sempre quella di leggere l’etichetta: i prodotti a basso contenuto di grassi saturi e di zuccheri semplici possono essere considerati di buona qualità.
In generale tutti i prodotti con la scritta light dovrebbero destare la nostra attenzione: spesso si tratta di alimenti con ridotto contenuto di grassi, ma ricchi di zuccheri, edulcoranti, additivi. Scelta dettata dal fatto che i prodotti devono comunque essere resi gustosi. Anche se ipocalorici, possono essere poco sazianti, e indurci a ricercare altri spuntini.
Falsi amici sono anche crackers e gallette di riso. Di solito consumati al posto del pane, nella convinzione che siano meno calorici. In realtà, contengono una maggiore quantità di carboidrati (quindi zuccheri) e di grassi. E diciamocelo: sono anche meno buoni! Il pane non è un nemico: basta consumarlo in quantità moderata, adatta al proprio stile di vita, meglio ancora se integrale per aumentare l’apporto di fibra.
Infine, anche un alimento che lascerà molte persone stupite: l’olio d’oliva. Ha un ottimo equilibrio di grassi, contiene antiossidanti e vitamine e certamente non può essere considerato un alimento poco salubre. Il problema è che il culto della dieta Mediterranea, pur facente parte del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, con l’adattamento alla vita moderna ha portato a degli eccessi. Tra questi ci sono i grassi: in una dieta equilibrata dovrebbero rappresentare il 25-30% delle calorie totali, ma nella dieta moderna superano facilmente il 50%. Ecco perché anche l’olio d’oliva, per quanto salutare, va consumato in quantità ridotte: la dose consigliata per una persona normopeso è di 3-4 cucchiai al giorno, compreso ovviamente quello utilizzato per cucinare.
Spero che la vostra alimentazione non conosca molti falsi amici. E ora che sapete a cosa prestare attenzione, vi auguro una buona colazione e una ancora migliore kolacja!
Italia ospite d’onore alla Fiera Internazionale del libro di Varsavia 2024
È stata siglata oggi (16.01.2024) presso l’Ambasciata d’Italia a Varsavia l’intesa che vede, per la prima volta, la partecipazione dell’Italia come paese ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Varsavia, in programma presso il Palazzo della Cultura e della Scienza dal 23 al 26 maggio 2024. L’intesa è stata sottoscritta per parte italiana da S.E. Luca Franchetti Pardo, Ambasciatore d’Italia a Varsavia, e, per parte polacca, da Waldemar Michalski e Jacek Oryl, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Storia e Cultura”, organizzatrice della Fiera.
La Fiera del Libro è un evento centrale nel calendario culturale della capitale polacca, e riunisce numerosi espositori provenienti dalla Polonia e da diversi Paesi del mondo.
 L’Italia sarà al centro dell’edizione di quest’anno con una ricca serie di eventi, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori e incontri tra operatori del settore: un’ottima occasione di conoscenza e promozione per il mondo editoriale italiano in Polonia. Come sottolineato dall’Amb. Franchetti Pardo “La fiera del libro di Varsavia, che quest’anno vedrà l’Italia quale ospite d’onore, rappresenterà una straordinaria opportunità per l’editoria italiana di promuoversi in un mercato di 40 milioni di abitanti che, come ho potuto sperimentare in diverse occasioni, nutre un profondo e sincero interesse, quasi “un’avidità”, verso la cultura italiana nelle sue varie manifestazioni”.
L’Italia sarà al centro dell’edizione di quest’anno con una ricca serie di eventi, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori e incontri tra operatori del settore: un’ottima occasione di conoscenza e promozione per il mondo editoriale italiano in Polonia. Come sottolineato dall’Amb. Franchetti Pardo “La fiera del libro di Varsavia, che quest’anno vedrà l’Italia quale ospite d’onore, rappresenterà una straordinaria opportunità per l’editoria italiana di promuoversi in un mercato di 40 milioni di abitanti che, come ho potuto sperimentare in diverse occasioni, nutre un profondo e sincero interesse, quasi “un’avidità”, verso la cultura italiana nelle sue varie manifestazioni”.
Il progetto della partecipazione italiana è reso possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura (Centro per il libro e la lettura -CEPELL) dell’Agenzia ICE e dell’Associazione Italiana Editori e coordinato, in Polonia, dall’Ambasciata d’Italia, dall’Istituto Italiano di Cultura e dall’Ufficio ICE di Varsavia.
Il fascino contemporaneo della maschera
Padovano, “teatrista” dal 1993, Andrea Pennacchi è autore e regista di opere tra le quali “Eroi”, “Mio padre – appunti sulla guerra civile”, “Una Piccola Odissea”. Coprotagonista della serie “Petra” per Sky e “Tutto chiede salvezza” per Netflix (vincendo il Nastro d’Argento), ha recitato in diversi film tra cui “Io sono Li” e “Welcome Venice”, entrambi per la regia di Andrea Segre, ne “La sedia della felicità” a firma di Carlo Mazzacurati e in “Suburra” diretto da Stefano Sollima.
Nel 2018 recita l’ormai celebre monologo “This is Racism – Ciao terroni”, grazie al quale viene invitato come ospite fisso a Propaganda Live (La7) e conquista il grande pubblico con la sua ironia pungente. Ha pubblicato “Pojana e i suoi fratelli”, “La guerra dei Bepi”, “La storia infinita del Pojanistan” (People, 2020 e 2021), e il recente “Shakespeare and me” (People, 2022). Attore e autore di spessore (con respiro internazionale) e capace di una disarmante schiettezza, Pennacchi è oggi uno dei volti più apprezzati del teatro e del cinema italiano, aggiungendo un pizzico di intelligenza anche alla televisione.
Andrea, come si inserisce il teatro italiano sulla scena europea?
Vedo un forte scambio a livello di formazione. Ci sono iniziative europee molto belle che portano a relazioni interessanti, soprattutto con l’Europa orientale. I grandi movimenti e i progetti condivisi di teatro di ricerca o di innovazione li vedo più fermi, mentre c’è una buona “esportazione” di Commedia dell’Arte e di abilità circensi, rispetto alle quali però c’è uno scambio con altri paesi che vantano una scuola di tradizione. Invece la Commedia è un patrimonio che portiamo nel mondo, perché lavorando sulle maschere, anche nella sua espressione più intellettuale o filologica, comunque rappresenta un esperimento interessante. È allo stesso tempo un teatro molto arcaico e molto pop. E poi lavorare sulla Commedia dell’Arte è affascinante perché deve per forza funzionare qui e ora. Ecco perché – tornando alla formazione – ci sono molti giovani europei che vengono in Italia soprattutto per studiare quella che è la nostra specialità.
Come si costruisce invece una maschera contemporanea?
Nella mia esperienza la maschera è una cosa che viene da te. Ovviamente non parliamo di Pantalone, Arlecchino e delle maschere della tradizione, che devi studiare per costruire la tua professionalità attoriale.
Parliamo invece di “maschere” come Fantozzi o come il tuo Pojana…?
Esatto. Fantozzi (per parlare di quello più famoso) è una cosa che viene da te e dopo un po’ ti accorgi che quel personaggio divertente che hai creato in realtà ha una profondità superiore rispetto alla macchietta o alla battuta da cabaret. È un’espressione che affonda le sue radici in una società e ne svela i lati oscuri. Improvvisamente ti accorgi che hai una maschera che funziona. Lo stesso è accaduto con Pojana. Franco Ford detto Pojana era nato nel 2014. Era il ricco padroncino di un mio adattamento delle “Allegre comari di Windsor” ambientato in Veneto, con tutte le sue fisse: le armi, i schei e le tasse, i neri, il nero. La prima evoluzione deriva dalla proposta della banda di Propaganda Live, che l’ha voluto sul palco in Tv. Ecco, da allora continua ad evolversi, si adatta a un presente che non manca di offrire spunti tragicomici.

Dove stanno le radici?
Volendo trovare una traccia comune nella tradizione della maschera, si torna ai drammi sacri di prima della controriforma, nei quali i dèmoni in scena vestivano grandi mascheroni da demone, appunto, e facevano ridere e spaventavano, ma dicendo delle grandi verità. La gente li ascoltava ed era la parte “creativa” di un culto. Lo stesso accade adesso: ci sono maschere, ogni tanto anche in televisione, che non sono la macchietta nata per far ridere o un personaggio superficiale, ma ti dicono: ‘sto parlando anche di te’. Come artista, con le mie maschere scelgo di parlare dei problemi e della nostra società e di riderne in maniera condivisa, nella speranza che poi qualcuno risolva anche questi problemi…
Tu hai detto che il Pojana è un demone di basso rango, non è potente, e allo stesso tempo che non è meschino ma ha una sua dignità. Cosa intendi?
Quando lo definisco un demone intendo che non è un uomo piccolo, come ce ne sono tanti. Ha una sua grandiosità, una sua cosmologia e una sua filosofia anche. Però è uno di quei piccoli demoni interessati a uscire dall’inferno più possibile, a stare meglio possibile, a tentare gli esseri umani per acquisire più energia. E alla fine gli interessano ‘sti umani, anche se in maniera negativa. Ecco, questo vale anche per il Pojana: non è cattivo, ma è chiuso dentro il suo mondo. Non è vero che questo lo renda piccolo, lo rende prigioniero dei propri stereotipi e probabilmente se fosse libero sarebbe più grande.
Pennacchi in Europa. Qual è stato e qual è oggi il tuo rapporto con questa grande casa che ci accomuna?
Io sono profondamente europeo. Tanto che, ad esempio, la Gran Bretagna a me manca e mi dispiace che siano andati via, perché in fondo sono un po’ come quei cugini che ti fanno arrabbiare ma poi ti mancano. Per me un’Europa forte e unita anche culturalmente sarebbe un elemento di salvezza mondiale. A livello culturale c’è una ricchezza infinita, perché ogni singolo paese d’Europa ha qualcosa di comprensibilmente e visibilmente europeo e però con delle peculiarità che lo rendono unico, come accade per il teatro o il cibo. Tutti hanno qualcosa da dare di arricchente e io mi sono nutrito di tutte queste cose, per cui mi piacerebbe riprendere a viaggiare attraverso il vecchio continente come ho fatto quando ero più giovane. Sono appassionato di letteratura e di parole da ogni territorio e da ogni tradizione. Peraltro ho avuto la fortuna di abitare a Praga per un periodo e di conoscere autori della parte orientale dell’Europa.
Esistono esperienze o legami con la Polonia?
In realtà non ho esperienze specifiche, non ci sono mai stato. Ho un carissimo amico d’infanzia che ora vive e lavora a Cracovia; ogni tanto mi invia foto molto belle e spero di riuscire prima o poi a raggiungerlo.
Parlando di Polonia e formazione teatrale non possiamo non citare Jerzy Grotowski…
Certo, però negli anni in cui Grotowski era al culmine del suo percorso lavorativo non c’ero. Ho invece avuto la fortuna di essere invitato al suo Workcenter di Pontedera e lì ho visto una delle cose più raffinate e più toccanti di cui ho fatto esperienza nella mia vita. Solo che non era teatro, perché ormai la sperimentazione dell’ultimo Grotowski andava verso dinamiche simili a un culto. Il percorso di ricerca era più simile a quello dei dervisci, avvicinandosi dunque a una forma di contemplazione mistica e quasi religiosa, ma aveva completamente perso la dimensione teatrale cioè non era più rivolta verso un pubblico. Eppure per me è stata un’occasione molto importante, perché ho capito che il teatro poteva avere anche quella profondità lì e di questo sono molto grato a Grotowski. Lavorando nel teatro, infatti, impari che si deve aver a che fare con i biglietti e i borderò e la burocrazia, ma non si può non avere a che fare con lo spirito, con l’anima, altrimenti il teatro diventa cose che uno dice su un palco. Invece il teatro è una cosa sacra e questo non lo dimenticherò mai.
In questo scenario come si colloca il tuo lavoro su Shakespeare?
Per me Shakespeare, sul quale sto lavorando in questo momento, rappresenta un grande collante per l’Europa. Nel suo percorso autoriale ha incontrato tutti i grandi fermenti che hanno reso importante il vecchio continente nel Seicento, ha preso i fermenti artistici e gli insegnamenti dei grandi pensatori, portandoli nei suoi testi. Sono fermenti che ancora agitano questo continente e infatti il mio sogno sarebbe fare uno spettacolo a partire da Shakespeare e portarlo in giro per l’Europa… per esempio in Polonia. (ride)
E poi torniamo a Omero che ha gettato le fondamenta…
Senza Omero non c’era Shakespeare, senza Omero non c’è l’Europa. Ne sono convinto, non lo dico per vezzo. Per secoli il curriculum base di tutti gli intellettuali erano i poemi omerici. Sì, poi c’è l’Eneide (che è una sorta di bignami…) ma alla fine tutto torna all’Iliade e all’Odissea.
Aosta Segreta
foto: Federico Moro
Aosta, capitale delle Alpi e crocevia d’Europa: storia, arte e leggende tra Dora Baltea e cime di ghiaccio. Accoccolata sul fondo della valle, la città respira al ritmo di una storia antica. Nevralgico punto d’incontro di strade che, un tempo, varcavano i passi del Piccolo e del Gran San Bernardo e ora anche il traforo del Monte Bianco, accoglie con le testimonianze di un passato affascinante. Saint-Martin de Corlèans ricorda epoche lontanissime e narra di misteriosi riti segreti dai significati e dai contorni a noi ignoti. Un racconto parla di Cordelo, discendente di Saturno e capostipite dei Salassi oltre che compagno di Eracle, il quale nel 1158 a.C. avrebbe fondato la città di Cordela, mentre i molti resti romani rievocano la sua nascita storica.
Attraverso il Medioevo ci giunge la profondità della voce di Sant’Anselmo, al quale è seguita una schiera di donne e uomini che hanno forgiato la storia e il sogno della città di luce sfumata nelle ombre allungate dalle montagne. Un paesaggio capace di produrre leggende in cui agiscono eroi, streghe, fantasmi, demoni e santi che danno vita a un universo cosmopolita e sempre in movimento. Come la città contemporanea, vitale come la corrente della Dora che transita veloce.
Aosta sono tre città: l’antica, la medievale e la moderna. Aspetti diversi, sottoposti a influssi lontani, eppure fusi in unità armonica che di continuo diviene e si trasforma, simile in questo alle montagne che la circondano, all’apparenza ferme testimoni della frenesia degli uomini e in realtà natura in cambiamento. Passeggiando nel chiostro di Sant’Orso, accarezzati dalle ombre pensose di quanti qui hanno riflettuto a lungo sul senso dell’esistenza e sul perché della morte, torna in mente l’antico dibattito tra chi sosteneva che «l’Essere è e nulla non è»1 e l’irriducibile rivale per cui «Nello stesso fiume entriamo e non entriamo, siamo e non siamo»2. L’Immobilità contro il Movimento, l’Uno abissale opposto alla Totalità del ciclo.
Un dubbio che ritorna passeggiando per gli assi ortogonali di vie che rimandano a un perfetto tracciato ippodameo3, voluto dai progettisti romani i cui progenitori l’avevano adottato per lo schema dell’accampamento mobile delle legioni: ragioni di sicurezza, di logica di montaggio, di disposizione razionale di funzioni specializzate, che si ritrovava nelle nuove fondazioni urbane, facilitandone con il pregio della serialità la realizzazione e il ritrovarsi degli uomini, tra gli schemi di una socialità già nota. Unità e Molteplicità, Stabilità e Cambiamento attraverso il fluire del tempo, come sottolineano le imponenti montagne e l’irrequieta Dora Baltea, sempre uguale eppure diversa.
Non è neppure vero che Aosta sia solo “tre città in una”: ne esiste, infatti, una quarta, collocata fuori dalla Storia e inserita nel Mito. La più sfuggente e per questo meno conosciuta. Relegata per secoli nell’ambito dei racconti tramandati oralmente e poi fissati su pagine di dubbia verità da mani attente alle sfumature e alla ricerca delle preesistenze. Poi, un giorno, il piccone rimuove la zolla giusta e il fantasma tante volte evocato si manifesta. Con la durezza della pietra e la straniante levità dei messaggi di ardua interpretazione. Allora si è costretti a riavvolgere il filo delle vicende umane per avventurarsi nelle pieghe di epoche schizzate solo con effetti impressionistici. Sfuggono i nomi, i luoghi diventano incerti, i fatti restano ignoti. Eppure, le testimonianze sono lì, davanti a noi e ci osservano beffarde nell’attesa di venire decifrate. Se mai riusciremo a farlo.

Ci stiamo solo accostando ad Aosta e già gli interrogativi si accumulano. Ritornano in mente Cordela e i Salassi, storicamente esistiti e ricordati nella titolazione della città romana: Augusta Pretoria Salassorum. Qui, però, sbattiamo contro una realtà molto più antica, sprofondata in un’epoca, il quinto millennio prima dell’Era Comune, dai contorni indefiniti e dai contenuti nebulosi. I misteriosi disegni su pietra veicolano messaggi ancora ignoti. Segni simili a tracce lasciate dagli elementi atmosferici sulle rocce. Forse una prova dello stretto legame esistente un tempo tra esseri viventi e ambiente.
Ironia vuole che le tracce ancestrali si trovino sul lato opposto della città rispetto a chi risalga la valle provenendo da Ivrea, cioè l’Eporedia dei Romani. Per noi, dunque, diventano quasi il punto d’arrivo di una visita che comincia, invece, con il ponte costruito per scavalcare il torrente Buthier ed entrare in città. Quasi un nascosto architetto del Cosmo avesse voluto far coincidere inizio e conclusione dell’avventura urbana, assecondandone una sorta di circolarità della vicenda esistenziale. La quale finisce per dispiegarsi davanti al nostro sguardo carica di suggestioni, nascoste dalla trama all’apparenza ordinata di una cortina di fatti ed edifici disposti secondo ferree regole. La Storia, invece, ancora una volta si dimostra soltanto la porta d’ingresso per un viaggio del tutto diverso: perché aperto, per chi lo voglia e abbia la giusta predisposizione d’animo, sull’Abisso della Conoscenza. La quale scintilla dal suo fondo in modo speculare al tramonto sui ghiacciai accoccolati tra le rocce, lassù in alto.
Mistico è un aggettivo che proviene dal greco mystikòs, a sua volta imparentato con il sostantivo mystêriòn. La radice comune è my- collegata al verbo my’ò: chiudere. Il mystêrion, quindi, si riferisce a quanto deve rimanere “chiuso”, nel senso di segreto. Servirà a indicare al plurale, mystêria, particolari culti ai quali si poteva partecipare solo dopo essere stati accettati e previo superamento di una serie di riti d’introduzione. A questo punto il fedele diventava mystês, iniziato.

Nel mondo greco antico, i misteri per eccellenza furono quelli di Eleusi, incentrati sulle figure divine madre-figlia di Demetra e Kore-Persefone. Senza dimenticarne altri, quali quelli di Samotracia con la coppia dei Cabiri, gli orfici e i bacchici, gli ultimi due di particolare diffusione nel mondo magnogreco e romano. La trasfusione della cultura misterica antica nelle vene della nuova religione nascente produrrà la mistica cristiana, tanto cattolica o d’occidente che ortodossa o d’oriente.
Esattamente come l’incontro tra la tradizione ebraica e la filosofia greca, in particolare con il neoplatonismo ellenistico, forgia in generale il cristianesimo, così la mistica affonda le proprie radici nella spiritualità degli antichi misteri e come questi affida la speranza dell’estasi, cioè della fuoriuscita dell’anima del corpo per l’ascesa spirituale capace di produrre l’incontro diretto con l’Abisso inconoscibile di Dio, all’illuminazione improvvisa che tutto rischiara e stravolge. Liberando dalle catene del corpo e proiettando il fedele nello spazio assoluto della verità.
A pensarci bene, non è poi quanto accade a chi sale quassù, percorrendo come è capitato a noi, l’antica via delle Gallie e si è inoltrato nella valle della Dora sino alla città magica sorta sul conoide del Buthier? Quando lo sguardo vaga tra le mute testimonianze del passato e alimentate da queste osa spingersi sino alle vette di montagne, tanto vicine quanto assise in un’indeterminata lontananza? E lassù si perde nel vuoto assoluto di spazi infiniti che ben rappresentano la perfetta pienezza del Tutto?
Vertigine di un pensiero completamente svuotato, anche da sé stesso; suono del silenzio che si tramuta in musica; sottile vibrazione che diventa immobilità: Aosta, dunque, è questa. Segreta perché satura di mistero e quindi mistica per chiunque abbia voglia e capacità per coglierne l’anima nascosta. La quale, a ben vedere, è invece sempre davanti a qualunque occhio appena attento, solo che sia sufficientemente “educato”, cioè iniziato. Perché il vero “segreto” di ogni luogo consiste nella sua Verità e questa semplicemente è sempre e comunque distesa davanti a noi.
Conosci ciò che ti sta davanti e ti si manifesterà ciò che è nascosto. Giacché non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato4.

Ci siamo mai soffermati a considerare quanto sia vero? Persino le scoperte più incredibili in realtà se ne stavano spesso là, quietamente, in attesa di qualcuno che, con grande semplicità, se ne accorgesse. È un dato di fatto. Accettato ovunque. A partire dalla comunità scientifica. Il nuovo è solo diversa sistemazione dell’esistente. Un rimescolamento di carte o, per essere più precisi, di tessere di mosaico. Se ci ostiniamo a seguire gli stessi criteri nel disporle otterremo solo disegni identici. L’illuminazione altro non è se non l’intuizione che fa guardare con spirito diverso i medesimi elementi. Forse la conoscenza è vaporizzata dentro e tutt’intorno a noi, data una volta e da quel momento disponibile per sempre e per chiunque. Il sapere, allora, diventa un continuo sforzo per ricordare. Come sosteneva Platone.
Da qui l’importanza della memoria e l’ossessione che alcuni avvertono verso la necessità della sua conservazione. A dispetto dell’azione demolitrice attuata dal tempo con l’aiuto dei troppi dimentichi di chi sono. Le pietre, sistemate con ordine dalla natura o disseminate nelle rovine, diventano aiuto prezioso. Assieme alla Storia e alle storie. Tutti elementi indispensabili per comprendere.
Una città è un organismo vivente: nasce, muta, può anche morire. Quando accade può non essere per sempre. Basta anche solo un uomo che, in momento di lucidità, ne parli perché scrittore, pittore, scultore, musicista, architetto perché vie e piazze riprendano a respirare, comunicando con noi. Un miracolo che supera i limiti dello spazio-tempo. Aosta è qui a dimostrarlo. Basta guardare, appunto. Sapendolo fare. Il viaggio è appena cominciato.
1 Parmenide di Elea, Sulla Natura, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, Milano, 1998, frammento 6
2 Eraclito di Efeso, Frammenti, a cura di Carlo Diano e Giuseppe Serra, Mondadori, Milano, 2001, frammento 16
3 Da Ippodamo di Mileto, l’architetto e urbanista greco al quale la tradizione rimanda per l’invenzione della pianta ortogonale nelle nuove fondazioni cittadine.
4 Vangelo di Tomaso, in Luigi Morialdi (a cura di), «Vangeli gnostici», Adelphi, Milano, 1989, p.6
Il Duomo di Amalfi visto e dipinto da Aleksander Gierymski
traduzione it: Maciej Wilińśki
Amalfi, pittorescamente situata sulla costa dell’Italia meridionale, era già una località affollata di turisti nella seconda metà del XIX secolo. La sua popolarità era certamente dovuta alla vicinanza di Pompei e di Napoli che, grazie alle scoperte e al rapido sviluppo dell’archeologia e della storia dell’arte, suscitavano un vasto interesse. Anche tra gli aristocratici polacchi si diffuse la moda di visitare questi luoghi. Il conte Potocki, tra l’altro, rimase affascinato dagli scavi e decise persino di esplorare l’interno del Vesuvio, descrivendolo in modo estremamente interessante nel suo resoconto della spedizione. Amalfi e i suoi dintorni furono dipinti da diversi artisti. Aleksander Gierymski, appassionato viaggiatore in Italia, fu ispirato dalla Costiera Amalfitana e vi realizzò almeno due dipinti e uno schizzo. Viaggiò verso sud nell’inverno del 1897 e immortalò la zona nei dipinti “Cattedrale di Amalfi” e “Veduta di Amalfi sulla costa”, purtroppo andato perduto (oggi conosciuto solo attraverso le fotografie). Realizzò anche uno schizzo del pulpito di una chiesa di Ravello, a pochi chilometri da Amalfi.
Si dichiarò un amante del Rinascimento italiano, studiò a Monaco di Baviera per quasi sei anni; si diceva che fosse il “sacerdote della luce”. Era anche perennemente insoddisfatto di se stesso e, secondo le testimonianze dei suoi contemporanei, aveva difficoltà a finire un quadro; aveva sempre un po’ di vernice in più sul pennello, sempre un tocco in più, una pennellata in più, una linea, una macchia, un riflesso del sole o grattando via con la spatola quello che c’era per crearne uno nuovo, diverso, migliore. Chi era Aleksander Gierymski e perché i suoi quadri nascevano nel dolore di infinite modifiche e alterazioni, ricominciando tutto da capo?
Il giovane Gierymski fu ammesso all’Accademia di Belle Arti senza esami grazie al fratello Maksymilian, che ormai vi studiava. Inizialmente si inserì nella comunità di Monaco, come veniva solitamente chiamata la colonia polacca di artisti che studiavano e lavoravano lì, e si modellò in qualche modo sul fratello maggiore. Molto presto trovò la propria strada come pittore. I suoi primi dipinti portavano il segno della sua ammirazione per i coloristi veneziani, in particolare di Tiziano e Tintoretto, che entrambi i fratelli potevano ammirare nelle ricche collezioni della Pinacoteca. Dopo qualche anno, Gierymski si recò in Italia e soggiornò principalmente a Roma, nonostante in questo periodo visitasse più volte Varsavia. Dipinse quadri italiani e scene realistiche di Varsavia.
La creazione del dipinto “Il pergolato”, raccontata da Stanisław Witkiewicz, divenne famosa e avvolta nella leggenda. Gierymski iniziò a lavorare all’opera già nel 1875, ma il suo fascino e i suoi esperimenti con la luce lo portarono quasi ad ammalarsi mentalmente. Soffriva di una nevrosi che, nel caso del suo lavoro pittorico, si manifestava in una morbosa cesellatura di ogni macchia di colore e di ogni dettaglio. Il processo di creazione del dipinto, la sua probabile distruzione da parte dell’artista, i frammenti o bozzetti dell’opera monumentale sparsi in vari musei, fatti e aneddoti, pettegolezzi e scandali legati al suo lavoro creativo sono materiale per un romanzo o un film, che furono utilizzati già nel 1963 nel film “Mansarda” diretto da Konrad Nałęcki. Gli autori si basarono sul racconto di Witkiewicz e sulle lettere di Gierymski. Witkiewicz scrisse del quadro “Il pergolato” che la composizione sembrava essere stata dipinta per anni, raschiata, tirata, tutti i mezzi pittorici portati all’ultimo limite e infine, in preda a un disperato sconforto, senza raggiungere il risultato voluto, (la composizione) è stata gettata nella cornice.
Nel corso del tempo Gierymski cadde sempre di più nella nevrosi. Verso la fine della sua vita, manifestò segni di malattia mentale. Soffre di depressione e muore in un ospedale psichiatrico italiano tra il 6 e l’8 marzo 1901.
Le sue opere vengono esaminate in due modi: da un lato, viene analizzato come realista, come pittore e cronista della vita dei poveri a Varsavia, evidenziando la sua visione reportagistica della realtà; dall’altro, la sua pittura viene confrontata con le tendenze dell’Impressionismo e con l’intera tradizione artistica della luce e dell’ombra. Vale la pena ricordare che lo stesso Gierymski riteneva che ci fosse molto da imparare dagli impressionisti, ma la sua pittura, in cui studiava in modo simile la luce, era una precisa costruzione dello spazio sulla tela e si distingueva per una grande disciplina nei dettagli. Si concentrava sul luminismo ma non rinunciava ai dettagli. Il dipinto proveniente dalla collezione del Museo Nazionale di Kielce “Cattedrale di Amalfi” costituisce una combinazione dei due punti di vista del pittore, se li prendiamo come punti di partenza per un giudizio. L’opera è sia una sorta di cronaca della vita in una città italiana alla fine del XIX secolo, sia un eccezionale studio sulla luce.
Il Duomo di Amalfi, le cui origini risalgono al XIII secolo, affascinava gli artisti con la sua architettura e divenne anche il motivo principale del dipinto di Gierymski. Il suo aspetto attuale è dovuto alla ricostruzione e alla riedificazione della seconda metà del XIX secolo, intrapresa dall’architetto italiano Enrico Alvini dopo il terremoto del 1862. Prima della catastrofe, la cattedrale aveva una facciata barocca, ma si decise di ripristinare l’aspetto del periodo più antico e di tornare allo stile arabo-normanno, tipico dell’Italia meridionale.
Il quadro di Gierymski può essere analizzato in termini di documentazione, e capita che venga paragonato alla fotografia. Vale la pena estendere questa visione e prestare attenzione a valori aggiuntivi che vanno oltre il mezzo moderno della fine del XIX secolo, che era la fotografia, ovvero considerare i colori e la luce oltre ai dettagli architettonici. La fotografia dell’epoca non offriva certamente una tale qualità e fedeltà, quindi l’immagine rappresenta un valore molto più elevato. La ripresa realistica era accentuata dalla presenza di persone. Oggi la cattedrale ha lo stesso aspetto, ma non ci sono fioriste con grembiuli colorati su ampie gonne, né uomini in cilindro che salgono le scale con signore altrettanto eleganti. Tuttavia, si può notare una certa convergenza e permanenza del luogo. Il sole splende sugli stessi edifici della piccola Piazza Duomo, sulla scalinata che porta alla cattedrale e sul tempio stesso. Le stesse montagne si accumulano sullo sfondo, la torre dell’orologio misura ancora le ore. Un tempo fiori, ora frutta. Nella piazza sotto la scalinata, in grandi ceste di vimini e cassette di legno appoggiate direttamente sul marciapiede, si vendono arance e limoni maturi della varietà sfusato amalfitano, per cui è famosa la regione amalfitana.
Gierymski dipinse il quadro nell'”ora d’oro”, poco prima del tramonto, i raggi del sole quasi illuminano le decorazioni sulla facciata della cattedrale. La pietra assume calde tonalità ambrate con brillanti riflessi di bianco. Sopra la metà della scalinata, la parte superiore che brilla al sole e la facciata della chiesa contrastano con la parte inferiore in ombra grigia, con la piazza del Duomo che si estende in primo piano. L’orologio sul campanile della chiesa indica le 17:20, l’ora in cui i raggi del sole sono più intensi, ma non arrivano più in tutte le parti. Grazie ai contrasti della luce e alla gestione del colore, il dipinto mostra che il terreno sale dal primo piano verso i giardini terrazzati e gli edifici che emergono tra la torre e la sommità della facciata, per stagliarsi contro il cielo con picchi rocciosi. Gierymski era un attento osservatore e aveva una grande consapevolezza del colore. La facciata della cattedrale e la torre dell’orologio risplendono nella luce che rende ancora più nitido ogni dettaglio architettonico. Per un edificio in stile arabo-normanno, questa era un’enorme sfida artistica, poiché la sua decoratività fu pensata per evocare stupore e giochi di luce sui numerosi dettagli scultorei e sulla pietra variegata generando un vero e proprio mosaico colorato e scintillante.
Come scrisse Bolesław Prus, che all’epoca parlava spesso dell’arte polacca, ‘Gierymski non è né un pittore di “genere”, né un pittore di “storia”, né un “fotografo”, ma piuttosto un sacerdote della luce, di cui ripercorre i misteri e ce ne insegna le bellezze’. L’opera potrebbe essere stata in parte realizzata all’aperto, ma sappiamo che Gierymski la completò solo due anni dopo, ormai a Parigi. Lo testimoniano la firma e la data in basso a destra: “A.GIERYMSKI 99”.
L’Amalfi di oggi offre ai turisti un’esperienza estetica simile a quella di cento anni fa? È una delle centinaia di città italiane che si vorrebbero visitare sotto il bel sole pomeridiano. A parte la Cattedrale di Sant’Andrea, con le reliquie di Sant’Andrea Apostolo portate in città dopo la quarta crociata, e il tentativo di confrontarsi con la fotografia contemporanea con il dipinto di Gierymski, ci sono alcuni luoghi bellissimi che meritano di essere visitati. Ad Amalfi non mancano e sono certamente in grado di attirare il nostro sguardo più a lungo, magari non per i due anni che Gierymski ha trascorso a dipingere la vista della cattedrale e le colline rocciose in profondità, ma almeno per un momento, per un bicchiere di limoncello fatto con limoni locali sotto l’ombrellone di un caffè in Piazza Duomo, per vedere se i colori del sole pomeridiano sono cambiati negli ultimi cento anni o per lasciarsi andare alla festa estetica dell’”ora d’oro” e percepire così il dolce far niente italiano.







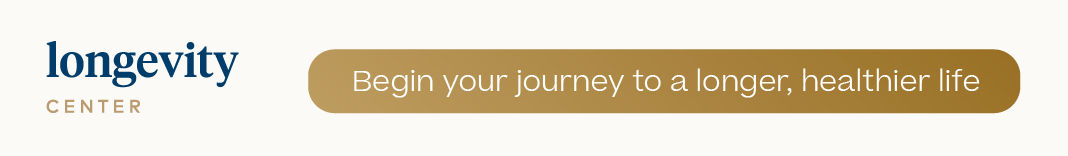















 Lei viene definita colorista, perché nei suoi dipinti cani, cavalli, uccelli sono astrattamente colorati, viola, arancione, blu.
Lei viene definita colorista, perché nei suoi dipinti cani, cavalli, uccelli sono astrattamente colorati, viola, arancione, blu.

