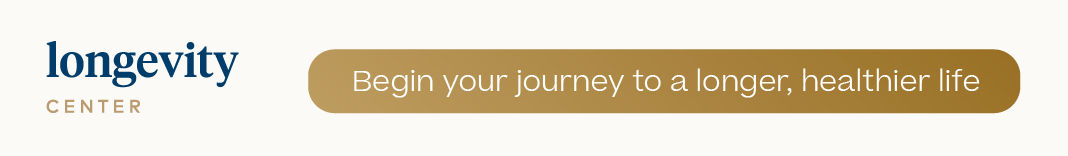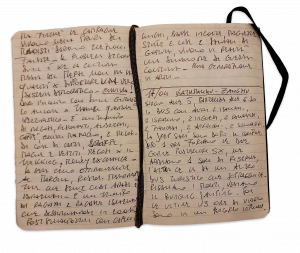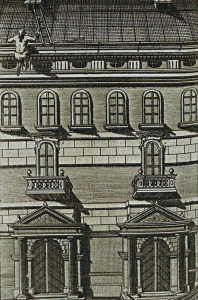In un qualche giorno del lontano gennaio del 1996 presi un treno dall’enclave cattolica di Goa. Colonia portoghese fino al 1961 e poi negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso meta cult dei viaggiatori europei alternativi, Goa è un piccolo stato indiano dalle bellissime spiagge che si affacciano dolcemente sul Mar Arabico.
Proprio in quei giorni Bombay, nome portoghese che significa “buona baia”, stava diventando Mumbai, scelta politica per allontanare ulteriormente il retaggio coloniale. Il viaggio in treno, con quattro classi di posti, che mi portava da Goa a Mumbai durò 22 ore, oggi ne dura 11 e 10 minuti.
Alla ventesima ora, esaurita ogni lettura, cartacea ovviamente, ma anche ogni più recondito slancio di scrittura sul taccuino nero Moleskine e consumata perfino la mia instancabile curiosità applicata sia nel guardare i paesaggi che scorrevano lenti fuori dal finestrino, sia nell’analizzare sociologicamente l’incessante mutare della fauna che viaggiava con me, entra nel mio scompartimento un ragazzo magrissimo, con una tunica bianca ed una valigetta. Mi si siede di fronte, nonostante ci sia il posto libero lasciato dalla molto più interessante giovane coppia di Sikh che avevo avuto come compagni di viaggio per le precedenti 20 ore. Lui alto e forte con un bellissimo turbante dalle calde tonalità gialle e rosse, con cui avvolgeva un misto di capelli e peli che secondo il sikhismo non vanno tagliati ma accettati quale espressione della volontà del Creatore. Lei una giovane, affascinante, madre dagli occhi blu che alternava l’allattamento al seno del pargolo ad affettuosi gesti di dolcezza verso il marito che ricambiava. Una visione che era un tale mix di bellezza estetica e forza della natura che l’avrei potuta seguire in loop per altre 20 ore.
Il ragazzo incurante della mia palese, ruvida, indifferenza, in parte giustificata dalla stanchezza, vuole a tutti i costi familiarizzare snocciolando una sequenza infinita di domande che mostrano uno spiccato interesse materiale nei miei confronti. Per capirci mi chiede anche quanto guadagno, oltre a quanti figli ho, quante stanze ha la mia casa ed altre amenità quantitative che mi fanno riflettere sui certi banali discorsi europei sulla spiritualità indiana. Di tanti paesi visitati sicuramente l’India mi è parso quello più materico.
La faccio breve. Mentre il treno lentamente scivola fino a fermarsi sui binari dell’imponente stazione Chhatrapati Shivaji, un tempo Victoria Terminus, diventata nel 2004 patrimonio dell’Unesco, tiro fuori la Lonely Planet, Bibbia dei viaggiatori pre-internet, dove ho già segnato sulla mappa alcuni alberghetti economici. Gesto che per il mio pedante compagno di viaggio è un invito a nozze, così attacca: “Ti porto nell’albergo di un amico?”
“Magari ti consiglio tra quelli della guida?”
“No!”
Il ragazzo non si perde d’animo e quando il treno si ferma completamente prende il mio zaino sorridente: “Te lo porto io”.
“Assolutamente no!” ribatto caricandomelo in spalla e cercando a passo veloce di seminarlo prima nel corridoio del vagone e poi in stazione.
Uscito sul piazzale cerco un taxi, il ragazzo mi precede ne ferma uno e mi dice eccolo qui.
“No! Me lo trovo io!”, ribatto con tutta l’esperienza che si accumula viaggiando soli, per settimane, in India dove spesso i consigli ricevuti su alberghi, ristoranti, negozi sono interessati. Chi porta un cliente ottiene una mancia.
Trovato il taxi mi volto e lo saluto bruscamente, lui con sguardo triste chiede:
“Potrei almeno salire in taxi con te e poi io proseguo?”
Uno slancio di empatia inavvertitamente squarcia la mia corazza umorale sviluppatasi tra stanchezza di viaggio e di relazioni: “va bene”.
Do le indicazioni al taxi. Quando arriviamo sotto l’alberghetto lo saluto in macchina tarpando il suo slancio nel volermi accompagnare in albergo per, secondo lui, aiutarmi a trattare sul prezzo.
 “Ma ci possiamo vedere più tardi?”
“Ma ci possiamo vedere più tardi?”
La domanda mi coglie di sorpresa, in pochi secondi realizzo che ho una fame bestiale accumulata in 22 ore di insufficienti spuntini.
“Ci vediamo lì tra un’ora”, indico con la mano un negozietto di cianfrusaglie.
“Bene a dopo!”, risponde felice il ragazzo tunicato.
Fatta la doccia, riprese un po’ di forze, scendo 15 minuti prima dell’appuntamento e mi piazzo all’angolo della strada da dove posso seguire l’arrivo del ragazzo senza essere visto. Può sembrare una eccessiva precauzione ma – come raccontato nell’ottimo serial “The Serpent” basato sui crimini di Charles Sobhraj a danno di sprovveduti viaggiatori – in questi casi è meglio tenere la situazione sotto controllo e assicurarsi che il ragazzo sia solo.
Scelgo il primo ristorante che trovo, ovviamente è vegetariano. A tavola il ragazzo, che ordina solo un the, continua per tutta la cena a parlare tra domande – cui non rispondo perché intento a rimpinzarmi di cibi buonissimi, piccantissimi e coloratissimi – e racconti, che ascolto distrattamente, sulla sua famiglia.
Finalmente satollo gli dico: “grazie della compagnia ma ora sono stanco davvero e torno in albergo”, lui sorride felice, ci scambiamo i contatti e chiedo il conto al cameriere che risponde: “ha già pagato il suo amico”.
“In che senso?”
“Per me è un gran piacere parlare e imparare cose da un occidentale”.
“Ma scusa tu non hai mangiato nulla! No, no lascia che ti dia i soldi della cena.”
“No assolutamente, faccio parte di quelli che qui chiamiamo bramini, siamo il vertice della società indiana e per noi è importante imparare dagli stranieri”.
 Sono basito e travolto dal senso di colpa per aver mangiato come un leone a spese di questo ragazzo, dalla vergogna per averlo trattato prima con ruvida freddezza e poi con distaccata superiorità e dal pensiero d’esser stato un pessimo esempio di straniero da cui non c’era nulla da imparare. Il mio pregiudizio era sbagliato, ho ricevuto una lezione di vita che oggi, 28 anni dopo, sento ancora con bruciante attualità.
Sono basito e travolto dal senso di colpa per aver mangiato come un leone a spese di questo ragazzo, dalla vergogna per averlo trattato prima con ruvida freddezza e poi con distaccata superiorità e dal pensiero d’esser stato un pessimo esempio di straniero da cui non c’era nulla da imparare. Il mio pregiudizio era sbagliato, ho ricevuto una lezione di vita che oggi, 28 anni dopo, sento ancora con bruciante attualità.
Questo è uno degli aneddoti vissuti in anni di viaggi in solitaria, partendo con biglietto d’aereo con ritorno aperto, uno zaino, con sacco a pelo per le emergenze, un Moleskine e la Lonely Planet. Ritagliando dalla quotidianità almeno un paio di settimane, possibilmente un mese, per scoprire paesi e culture che visitavo e visito immaginando ogni volta come sarebbe viverci, provando la cucina locale, rifuggendo proposte culinarie globali e aprendomi a nuove amicizie verso i locali o gli altri viaggiatori. Una filosofia di viaggio che si fonda sul desiderio di imparare per tornare arricchiti non solo di oggetti esotici ma, soprattutto, di esperienze e ricordi che rimangono indelebili.
Spesso durante il viaggio regalo le magliette che mi porto da casa per far posto ai nuovi acquisti – tovaglie guatemalteche, sciarpe di cachemire nepalesi, elefantini ferma libri indiani, braccialetti masai – con il piacere di pensare che quei miei indumenti chissà per quanto vengono poi usati da qualcuno sul lago Titicaca o sull’isola di Sulawesi.
Non sempre si ha la fortuna di avere il tempo e le risorse per viaggiare a lungo in paesi lontani, si ha però sempre – anche passando un weekend in qualche città europea, tornando in un luogo già visto, o perfino visitando un posto a due passi da casa – la possibilità di scegliere che tipo di approccio vogliamo avere verso il mondo.
Quando girando per la mia città, Venezia – cui non mancano certo le attrazioni culturali e gastronomiche – vedo turisti (non viaggiatori) sostare per più di mezz’ora per prendere due palline di gelato in una determinata gelateria mi chiedo quale sia la loro scala di priorità visto che spesso hanno solo un giorno (!) per visitare Venezia.
Lo so, lo so, nell’era internet tutti guardano prima online i luoghi dove andranno e leggono le recensioni di locali, alberghi, negozi. Ma proprio per questo perché non evitare i luoghi “must”? Perché invece di accodarsi alla massa non distinguersi scoprendo qualcosa di nuovo? Avendo così poi ricordi inediti da raccontare? E se si ha poco tempo è mai possibile sprecarlo in coda di qualche locale consigliato da chissà quale sedicente esperto invece di sfruttare ogni minuto per fare esperienze autentiche? Le buone gelaterie non mancano in Italia, manca invece il tempo per vedere l’infinità di bellezze che il paese offre.
Per secoli le famiglie benestanti mandarono i loro figli a fare il Grand Tour in Italia, e in altri paesi europei, quale forma di investimento culturale e sociale. L’esperienza di viaggio era elemento educativo essenziale per la crescita individuale. Il fatto che oggi possiamo muoverci più facilmente e vedere virtualmente online il mondo non deve farci perdere il senso ed il piacere del viaggiare, né tantomeno l’individualità della nostra esperienza, che se non è personale e vera non è esperienza ma semplice replica d’esperienza altrui.
Il significato della parola esperienza: conoscenza pratica della vita o di una determinata sfera della realtà, acquistata con il tempo e l’esercizio; ci dà le coordinate su cui allineare il nostro viaggio: tempo ed esercizio pratico.
Prima di quel viaggio in India, come d’abitudine, avevo letto un po’ su quell’enorme incredibile paese e praticamente studiato la Lonely Planet. Ma non sono mai partito per un viaggio per trovare quello che avevo immaginato seduto sul divano di casa. Se il viaggio non ci sorprende e non ci arricchisce, cambiandoci, non è un viaggio. Se si parte per avere la conferma del nostro pregiudizio, ovvero di quello che si crede di sapere su un paese, non si è viaggiatori ma turisti che seguono percorsi confortevoli quanto banali.
Nell’anno delle celebrazioni di Marco Polo lasciatemi dire che rischiare d’essere turisti invece che viaggiatori è ancora più grave!